È certo che l’illimitatezza appartenga al pensiero umano, sopratutto quando si rapporta alla grandezza. Probabilmente è impossibile ridurre la suddetta amplificazione umana, applicatasi al cinema, a soli diciotto film, ma questo è stato il nostro scopo, umile, parziale, ma si spera, per quanto possibile, riuscito.
Ecco i diciotto migliori film di sempre secondo La Settima Arte. L’ordine è casuale.
1. La Finestra sul Cortile (di Davide Leccese)

Dal maestro del brivido Alfred Hitchcock, uno dei film più ansiogeni mai realizzati. Il suo più grande punto di forza è la capacità di mettere lo spettatore perfettamente nei panni del protagonista, arrivando a un’identificazione quasi totale. Il pubblico non solo vede ciò che vede il protagonista, ma arriva a capirne e condividerne i pensieri, i dubbi e i sospetti.
Lo stesso personaggio interpretato da James Stewart è in una situazione simile a quella di uno spettatore: è impotente davanti a una finestra a osservare ciò che succede nel palazzo di fronte senza poter intervenire, così come chi è seduto in sala a osservare gli eventi che scorrono sullo schermo.
Questo avviene perché il film è girato interamente in un unico ambiente, la casa del protagonista, immobilizzato su una sedia a rotelle dopo essersi rotto una gamba. Gli altri personaggi vanno e vengono, ma noi, come lui non li seguiamo mai.
Hitchcock attraverso la sua telecamera ci guida, ci mostra ciò che lui vuole che vediamo, attraverso gli occhi (e il binocolo) del protagonista. Il regista ci porta un momento a domandarci con lui se l’inquilino di fronte abbia ucciso la moglie, quello successivo a chiederci se L.B. Jeffries sia solamente paranoico. In questo modo lo spettatore è in costante stato di dubbio, non può mai sapere cosa realmente avvenga nell’appartamento di fronte, passando da un’idea all’altra e creando un costante stato di tensione.
Un’altra colonna portante del film è il modo in cui ci mostra come tutti possano essere fraintesi. Il messaggio che ci comunica è il fatto che non si possono mai conoscere realmente delle persone sulla base di semplici frammenti, che spesso possono ingannare e portarci a conclusioni sbagliate.
In sostanza La finestra sul cortile vuole essere un film su apparenza e realtà, tra illusione e concretezza, mostrando come queste possono incontrarsi e allontanarsi molto più facilmente di ciò che pensiamo.
2. Birdman o l’imprevedibile virtù dell’ignoranza (di Giacomo Simoncini)

Di cosa parliamo quando parliamo di amore? Che cos’è l’imprevedibile virtù dell’ignoranza? Tra un piano sequenza e l’altro Alejandro Gonzàlez Iñárritu prova a spiegarcelo con questo meraviglioso film.
Riggan Thompson è una star che ha raggiunto il successo planetario nel ruolo di Birdman, supereroe alato. La celebrità però non gli basta, vuole dimostrare di essere anche un bravo attore. Decide allora di scrivere, dirigere e interpretare l’adattamento del racconto di Raymond Carver Di cosa parliamo quando parliamo d’amore.
Il film si svolge in un groviglio di corridoi labirintici quasi quanto la confusa mente degli attori. Ma quali attori?! Quelli reali o quelli che recitano nel film? Il dualismo costante tra realtà e irrealtà si fa sempre più crescente con il passare dei minuti, così come l’abbattimento della quarta parete cinematografica.
Michael Keaton, che interpretò Batman nell’ormai lontano 1989 (niente lasciato al caso daIñárritu), veste alla perfezione il ruolo di star incompresa e ritenuta da tutti incapace di recitare. Edward Norton interpreta un personaggio fin troppo odioso, incapace di vivere nella vita reale e amante della vita teatrale. Emma Stone è perfetta nel ruolo della figlia appena uscita da una clinica di rehab.
Un meta-cinema/teatro pirandelliano che si colora di luci teatrali mischiate a giochi di specchi e trasparenze. Un cinema, quello del regista messicano, che parla di noi: delle nostre vite torturate dalla tecnologia e dalla realtà virtuale, dalla ricerca di un ego, di una etichetta, di una imprevedibile virtù dell’ignoranza. Tutto questo accompagnato da riff e fill di chitarra che fanno sembrare la colonna sonora essenziale quanto perfetta.
Il reale e l’irreale continuano a mescolarsi nella storia e nella testa degli spettatori fino alla scena finale: Riggan è in ospedale e si guarda allo specchio. Il resto, come direbbe il grande oratore, è storia. Sì, ma quale?! Quella del film o quella del nostro mondo reale?
«Finzione! Finzione! Urlano gli attori, mentre il Padre risponde: Ma quale finzione, realtà! Realtà, signori, realtà!»
(Sei personaggi in cerca d’autore, Luigi Pirandello)
Leggi Anche: Perché Birdman è un capolavoro?
3. Blade Runner – Più umani degli umani (di Tommaso Paris)

Profetico, Rivoluzionario, Filosofico, Poetico.
Ecco Blade Runner.
Un film che oscilla tra la fantascienza e il noir, tinteggiandosi di pennellate filosofiche ed esistenzialiste. Un’opera che non conosce, ma invece sovrasta i limiti del tempo. Un capolavoro non replicabile. Un film che ha l’ardire di creare un nuovo genere, diviene il padre di tutta una fantascienza consapevole di se stessa e di ciò che può donare.
Blade Runner trattando la tematica dei replicanti spalanca inevitabilmente le porte a domande universali. Viene decostruita la nozione di soggetto, di identità personale a noi conosciuta, siamo così costretti ad affrontare qualcosa che è più umano dell’umano. Ma che cosa vuol dire essere umano? Ciò ci fa dubitare, sospettare, mettere in discussione le nostre certezze.
Ridley Scott, attraverso uno sfondo estetico di immagini e sfumature magiche, accompagnato da una colonna sonora che ti permette di esperire un vero e proprio altro mondo, ci mostra la poesia che si cela nell’inestricabile complessità del reale.
L’autore svela le possibilità che nasconde l’esistenza, costringendoci a guardare il mondo con occhi autentici, manifestando la fragilità di bene e male, di luce e ombra, che si dissolvono proprio «come lacrime nella pioggia». Perdiamo così ogni ancoramento, non siamo più in grado di distinguere tra reale e fittizio, tra umano e replicante. Ci sveliamo a chiederci se effettivamente i replicanti sognino pecore elettriche. Che poi cos’è veramente illusorio?
Blade Runner, un cult eterno sul valore della morte, sul senso dell’esistenza e sull’incombente peso della libertà, in un mondo postmoderno a noi prossimo. Un film indimenticabile che non si disperderà «come lacrime nella pioggia».
«Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi».
(Blade Runner)
Grazie a questo film sono state rese possibili immense opere d’arte cinematografiche, che altrimenti non avremmo nemmeno potuto immaginare.
Leggi Anche: Blade Runner – L’Essenza della Vita
4. Il Cavaliere Oscuro (di Andrea Martelli)

Non è un semidio, non è un mutante e non sa volare. Batman è sempre stato uno di noi. E come tutti noi ha le sue paure e le sue umane debolezze. Con la trilogia di Nolan si naviga nell’oscurità dell’animo di Bruce Wayne, e il nostro Caronte è raffigurato nel favoloso Joker di Heat Ledger. È un criminale folle e senza passato (il che lo rende ancora più inquietante), col solo scopo di generare caos.
Egli rappresenta anche l’altra faccia della medaglia del vigilante mascherato: così come Batman non sarebbe mai esistito senza la presenza di criminali come Joker, questo non sarebbe mai potuto nascere senza l’abbattimento di quella sottile linea tra legalità e negazione di essa che lo stesso Batman scavalca continuamente.
Così lo scopo del Joker (e dello stesso Nolan) è vedere «quanto è profonda la tana del Bianconiglio» dell’animo umano, giocando con le persone per far emergere quella parte buia che risiede in fondo a ognuno di noi. Perfino nel procuratore distrettuale Hervey Dent, vero fulcro dell’intero film, che rappresenta il cavaliere di luce della città di Gotham.
Il clown, portatore di scomode metafore su princìpi e moralità, ci sbatte in faccia il mondo reale in cui viviamo, con tutte le falsità quotidiane e le apparenze che lo permeano. E se anche l’uomo più retto e giusto della città viene trascinato nell’oscurità più profonda, allora Nolan ci porta a delle profonde riflessioni personali e, in fondo, a dubitare perfino dell’eticità dell’uomo stesso.
«La follia come sai è come la gravità. Basta solo una piccola spinta».
(Joker, Il Cavaliere Oscuro)
Leggi Anche: Joker – La Logica del Caos
5. American Beauty (di Silvia di Conno)

L’intima bellezza nascosta nel mondo è la trama di cui è intessuto American beauty, straordinaria pellicola cinematografica del 1999, scritta da Alan Ball e diretta da Sam Mendes.
Un Kevin Spacey al meglio delle sue potenzialità dà voce all’arrendevolezza di Lester Burnham, un uomo sulla quarantina che, senza arte né parte né nulla da perdere, si trascina rassegnato all’uguaglianza dei giorni che si susseguono, troppo grigi e fiacchi perché lui possa sentirsi in grado di farli diventare qualcosa di nuovo.
È sposato con Carolyn (Annette Bening), una narcisa esclusivamente concentrata a costruire per gli altri un’immagine di sé che sia di una donna felice e in carriera: ella -come tutti i narcisi – vive sull’orlo della depressione per l’insuperabile divario tra la sua immagine ideale e quella reale.
In un film che ruota prevalentemente attorno alle immagini, sostituendo quindi la portata della parola con i corpi vivi e al tempo stesso fissi, bloccati nell’abisso dell’attimo in cui si rendono visibili in un’unica forma piuttosto che in altre, il frammento di mondo che fa di nuovo sentire vivo Lester è la bella Angela Hayes (Mena Suvari), una ragazzina di appena sedici anni amica di sua figlia Jane (Thora Birch).
Il rosso fuoco di petali di rose in cui Angela è immersa nelle fantasie di Lester è l’immagine che fa da fil rouge di tutta la storia, il filo di Arianna che permette di orientarsi in una labirintica realtà fatta di segreti e storie parallele che si intrecciano. Il loro cadere e posarsi finisce con l’essere quasi il correlativo oggettivo dell’idea fissa di Lester: ogni scena della sua vita diviene poeticamente incorniciata dalla fantasia di questi petali che, apparentemente apparsi come cornici, si insinuano di fatto come parti integranti della realtà, divenendo sempre più prepotentemente presenti.
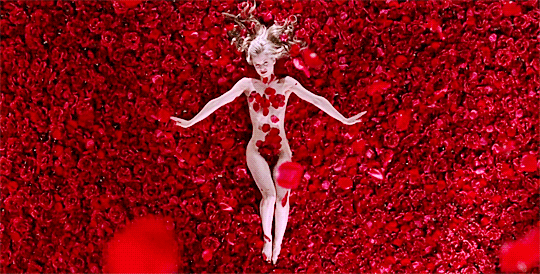
Si ha dunque la grandiosa possibilità di essere spettatori in itinere di come un pensiero sotto forma di immagine divenga un’idea fissa che gradualmente monopolizza totalmente la mente, prosciugando l’energia, impedendole di svolgere qualunque altro tipo di attività. È così dunque che Lester comincia a vivere in funzione della sua fissazione, incanalando le sue attività quotidiane al solo scopo di soddisfacimento di questa.
Questa modalità di reazione all’idea fissa è paragonabile allo sforzo di Gatsby che continua ostinato a inseguire il suo sogno di ritrovare Daisy, il suo amore giovanile, rendendo il suo palazzo e le sue feste sempre più sfarzosi.
Questi tentativi donchischiotteschi si consumano entrambi in una “dolce follia che finisce in tragedia”, vittime del principio di entropia che contiene in sé la sua infinita possibilità di autodividersi in frammenti di vita paradossalmente sempre più entropici del sistema che li contiene. In altri termini, dunque, il caos genera piccole porzioni di caoticità sempre più irrimediabilmente dispersive del fondo originario da cui si sono tratte.
Leggi Anche: American Beauty – Requiem per un sogno mai stato reale
6. Il Grande Lebowski (di Carmine Esposito)
Nell’universo del fanart sul film dei fratelli Coen, c’è un’illustrazione che svetta su tutte le altre: una copia di Night Hawks, il quadro forse più famoso di Edward Hopper, dove gli ospiti del Diner sono sostituiti dal trio drugo, Walter e Donny.
I clienti del Diner colpiscono l’osservatore per il loro totale distacco rispetto all’ambiente circostante, situazione in cui i tre protagonisti del film si infilano come in un guanto, quando al bancone del bar della sala da bowling bevono una birra tra una partita e l’altra, totalmente incuranti di quello che gli succede intorno.
Infatti, il drugo è forse il primo protagonista di un film a essere de facto non protagonista. Il personaggio ha ispirato un gran numero di cinefili per la sua flemma, tanto da spongere alla creazione di una sorta di religione chiamata duedism, che lo ha assurto al ruolo di profeta. Ma oltre a non farsi trascinare dagli eventi, il drugo scivola nella storia senza avere un reale ruolo influente.

Ci lasciamo prendere tra un white russian e l’altro, seguiamo con interesse l’andamento del torneo di bowling, ci appassioniamo alla vicenda del tappeto, ma soffermandoci sulla trama principale (quella del rapimento) rimaniamo con un dubbio amletico: qual è l’apporto del nostro affezionatissimo? Non trova la vittima, non consegna i soldi, non dimostra l’inganno della valigetta, non incastra il produttore.
Come nel “romanzo russo” di Carrere, il capellone impigiamato si ritrova a vivere tante storie, ma nessuna di quelle è la sua. Un po’ come tutti noi, sempre appassionati da talent, soap opera o divi dello spettacolo, ci ritroviamo a sognare mille e uno vite che non ci appartengono, e troppo spesso a rincorrerne l’illusione. Il drugo invece no, è contento nella sua vestaglia e non invidia il Grande Lebowski, il vero protagonista a cui per una volta ha rubato la scena.
Leggi Anche: L’Estinzione degli Hippies Californiani
7. La parola ai giurati (di Gabriele Fornacetti)
Non è facile giudicare. Richiede conoscenza, intuizione, comprensione di ciò che è causa e ciò che è effetto.
Potrei apparire esagerato, ma è un rischio. Un rischio dove non esiste vittoria, un rischio dove la sconfitta è più che prossima.
Dire la propria vuol dire esporsi ed esporsi non è mai facile. Siamo diversi e, laddove non la si pensa allo stesso modo, scatta la critica. Una critica troppe volte feroce, funesta, fortemente invasiva e integerrima. La parte più bella e più brutta del gioco, ma pur sempre una parte del gioco. E per questo sono pronto a giocare.

12 Angry Men, l’esordio alla regia di Sidney Lumet, uno dei più grandi capolavori della Settima Arte. La storia di Davide contro Golia, di un uomo, un immenso Henry Fonda, contro undici giurati convinti della colpevolezza di un giovane afroamericano nonostante i se e i ma. Un film del 1957 che, dopo sessant’anni, è ancora più attuale che mai.
La lotta contro il pregiudizio, che si chiami razzismo, omofobia, o qualsivoglia altro nome, è una lotta estenuante, faticosa, ed estremamente complessa. Ma è una lotta per cui val sempre la pena combattere. Per coloro che vorrebbero, ma non ne hanno la forza, per avere un mondo più equo, magari più libero, per far sì realmente che “La Legge sia uguale per tutti”, per la speranza di cambiare le strade del destino anche se il fato ha già deciso e per gli ultimi, i dimenticati, gli indifesi, gli emarginati. Insomma per gli altri, ma in primis per noi.
Un sogno, forse un’utopia, ma un desiderio che anche dopo moltissimo tempo è rimasto inalterato. Un miraggio che forse non si realizzerà mai, ma un motivo per cui continuare a crederci.
«In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario».
(George Orwell)
Oltre ogni ragionevole dubbio.
8. Interstellar – L’armonia nella polarità astronomica (di Andrea Sciannimanico)

Da sempre l’uomo punta il proprio sguardo al cielo, verso quell’infinità di spazio caratterizzata da un’eterna guerra tra luce e oscurità. Interstellar, per chi come me ha passato parte della propria vita a guardare il cielo, rimanendo a bocca aperta per la bellezza assoluta che ci circonda, sognando un giorno di attraversare quella lucente oscurità che ci fa sentire così piccoli, soli e isolati, non può che essere il miglior film.
Interstellar fornisce speranza nella scienza e nell’uomo. In un mondo ormai prossimo al proprio epilogo, solo queste due entità possono riuscire a salvare l’intera razza umana.
Ciò che però è davvero fondamentale in questo film sono sicuramente i sentimenti, dipinti in chiaroscuro nello spazio cosmico: la rabbia di Murphy, ancora troppo piccola per capire la scelta del padre di abbandonarla, contrapposta all’amore dello stesso padre, pronto a qualsiasi sacrificio pur di mantenere la sua promessa; la rassegnazione di Tom (il fratello di Murphy) e la speranza di tutti quelli che continuano a cercare una soluzione, la paura del Dr. Mann e il coraggio di Joseph.
I dialoghi di Interstellar sono protagonisti della trama. Solo prestando particolare attenzione ai discorsi tra i vari personaggi è possibile capire il flusso di informazioni che il film ci rilascia continuamente.
La fotografia ha un impatto visivo tale da shockare lo spettatore. La colonna sonora di Hans Zimmer, in perfetta sintonia con il film e con gli attori, trasmette allo spettatore le stesse emozioni che provano i personaggi della vicenda. Tutto questo riesce a creare un’atmosfera che rapisce e chi guarda si immerge totalmente nella visione.
Non è facile parlare di scienza senza cadere nella superficialità o, al contrario, usare termini troppo complicati: relatività del tempo, Wormhole, teoria delle stringhe sono spiegati in maniera semplice, ma mai superficiale. Come può non essere definito uno dei migliori film?
Leggi Anche: Interstellar – La Metafisica dell’Amore
9. Stalker (di Francesco Gamberini)

In una remota area industriale chiamata Zona esiste un luogo capace di soddisfare qualunque desiderio: la Stanza. Le autorità hanno isolato questo angolo di mondo dove parecchi anni prima sarebbe atterrato un meteorite, sprigionando un’energia misteriosa.
Uno scrittore e uno scienziato, accompagnati da una guida, lo Stalker, si avventurano nella Zona, ma giunti alla meta, decidono di non entrare nella Stanza.

Il quinto film di Tarkovsky inquieta e affascina per la sua compattezza: il regista ci porta fisicamente e psicologicamente in un universo pericoloso ed eccitante in cui l’irreale è sempre presente.
Senza alcun effetto speciale, egli crea un cinema di fantascienza, svuotato da ogni riferimento spaziale o temporale e ambientato in una dimensione piena di misticismo. Il sentimento che ci trasmette il film è un timore costante verso qualcosa che non si può conoscere. Ed è proprio questa vaghezza a rendere il film meraviglioso.
Non a caso infatti il regista non faceva mai leggere l’intero copione agli attori, ma li lasciava all’oscuro della storia, così da creare in loro delle emozioni autentiche.
Intriso di filosofia e poetica, la riflessione intimista traspare attraverso la parola (imponenti dialoghi e monologhi), ma soprattutto attraverso le immagini: lente carrellate a piombo sui protagonisti e zoom fulminei si alternano a lunghe inquadrature fisse, mescolando perfettamente stasi e movimento, azione e pensiero.
Qui più che mai Tarkovsky utilizza l’elemento dell’acqua in chiave allegorica come simbolo della contrapposizione tra flessibilità e forza.
Inoltre l’alternanza di bianco/nero seppiato e colori è significativa. Il bianco e nero viene usato per il mondo ordinario, mentre i colori vengono usati per la Zona. Il fatto che l’ultima immagine del mondo ordinario sia a colori ci comunica che la vera immaterialità non si trova in un luogo fisico lontano e irraggiungibile, ma si trova dentro di noi, nel mondo sensibile.
Stalker si distacca dal mondo sensibile per giungere a una dimensione più profonda della realtà, suscitando emozioni che mille parole non potrebbero descrivere.
Leggi anche: Lo specchio di Tarkovsky- Tra immagini implose e memoria
10. Arancia Meccanica (di Davide Leccese)

In uno dei suoi film più celebrati Stanley Kubrick racconta la complessità della natura umana, mettendo al centro la dicotomia tra caos e controllo. Lo fa raccontando l’arco di uno dei più famosi psicopatici della storia del cinema: Alex DeLarge.
Alex è un protagonista negativo che si lascia governare dai suoi impulsi, in particolare i più bassi che un essere umano possa provare. È attratto in maniera viscerale dalla violenza, ama fare del male per il gusto di farlo, senza porre particolari distinzioni tra le sue vittime. Si tratta di un personaggio intelligente e caotico, che agisce senza tante riflessioni su ciò che fa.
Quando però viene incarcerato, il suo modo di essere finisce a confrontarsi con una visione completamente diversa: quella della “cura Ludovico”, che ambisce alla riabilitazione dei carcerati attraverso un sistema estremo di punizione positiva.
L’obiettivo è rendere impossibile la recidività, portando il detenuto al rifiuto totale della violenza. Si tratta di una ricerca del controllo, volta a un cambiamento forzato della personalità del soggetto. Con Alex si ottiene il risultato sperato, ma è abbastanza difficile capire se Alex sia cambiato o debba semplicemente convivere con gli effetti del trattamento subito. È qui il fulcro del film.
Da un lato c’è la sicurezza e il controllo eccessivo da parte di una società che è disposta ad andare oltre ogni idea di diritti della persona pur di garantirla. Dall’altra troviamo l’idea di scelta personale, un diritto umano basilare, ma che se non incontra limitazioni porta a danni enormi verso la collettività.
Quello che il film vuole mostrare è come non ci sia una risposta, come non si possa lasciare totale libertà, ma allo stesso tempo la sua totale soppressione sia al di là di ogni umana comprensione. Ed è proprio questa profondità a rendere Arancia Meccanica uno dei capolavori del ventesimo secolo.
Leggi Anche: Arancia Meccanica – La Fenomenologia della Violenza
11. 8½ di Federico Fellini (di Francesco Malgeri)
Difficile, se non impossibile, trovare in 8½ una traccia, una trama, che rispetti canoni e registri, un intreccio narrativo che si inserisca nello scenario cinematografico convenzionale. 8½ è un viaggio: insensato, profondo, confuso, a tratti spirituale.

Mai come in questo caso Marcello Mastroianni rappresenta l’alter ego del maestro Fellini, interpretando la figura di Guido Anselmi, un regista in riposo in un lussuoso albergo pronto a girare un film di cui, di fatto, non sa nulla.
Un film che esiste solo ed esclusivamente nell’oscurità del suo inconscio; si aggira così in una dimensione rarefatta, irreale, tra terme di lusso, fugaci contatti con i suoi perplessi collaboratori, immersioni oniriche nei suoi ricordi d’infanzia e rievocazioni di un passato lontano e offuscato nella speranza di ritrovare la luce dell’ispirazione artistica.
La meraviglia che desta ogni sequenza di questo film ha segnato generazioni e generazioni di registi.
Mastroianni non incarna solamente l’immagine del regista in crisi d’ispirazione: è il ritratto di un uomo sperduto nei meandri di una vita di cui non trova il senso, di un’esistenza che manca di significato, schiavo di un turbamento che lo porta a domandarsi se esista veramente un qualcosa che lui voglia dire. Fino a raggiungere la frustrante coscienza che il suo smarrimento professionale rispecchia un intrinseco smarrimento vitale.
Solo al tramonto del viaggio, Guido abbraccerà la più preziosa delle consapevolezze: tutte le ragioni, i discorsi, le parole che ogni giorno si frappongono tra noi e la vita non hanno peso, vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. E allora perché sfuggirla, perché ignorarla, perché continuare a nasconderci da essa con l’illusione di attribuirle un qualche senso, etichettarle un qualche significato? Perdersi in essa è l’unico significato.
Questa morale fa di 8½ un film fondamentale. E ce la mostra, Fellini, nella sua intera filmografia: un continuo e inestricabile intreccio tra sensazioni interiori e deformate realtà fisiche; un infinito vagabondare in uno squallore macchiato da sogno e illusione.
Perché la vita non è che questo: un confuso e insensato danzare, in un carosello ove ogni volto, ogni impressione, ogni incontro fa parte di noi. E non esiste identità, immagine, nomea. Non esiste senso o logica: se è vero che la vita è una festa, viviamola insieme.
12. Star Wars Episodio V – La fantascienza tra mito e cinema (di Gianluca Colella)
Il set privilegiato dei migliori film della storia è sicuramente dato da quelle storie che, nelle loro sfumature, dipingono spazi a noi familiari, terrestri. Quello che non dobbiamo tralasciare è che negli anni Ottanta il cinema ha superato le barriere della fisica e ha deciso di conquistare una porzione di Universo in quella cara galassia lontana lontana, grazie alla fantasia di George Lucas.
La trilogia originale di Star Wars rappresenta l’origine di un fenomeno culturale senza precedenti, capace di appassionare milioni di spettatori per oltre trent’anni. Nel caso di quest’opera, il cinema non rappresenta altro che il mezzo attraverso cui l’opera giunge ai fan.
Dopo le battaglie di Una Nuova Speranza e la distruzione della Morte Nera, la saga della Forza si impone prepotentemente nella storia del cinema con il secondo capitolo, L’Impero Colpisce Ancora (1980). L’elemento centrale resta la battaglia tra il malvagio Impero e l’Alleanza Ribelle, ma allo stesso tempo cresce la connessione del pubblico con il protagonista Luke Skywalker, alla ricerca di un maestro dopo la morte di Obi-Wan Kenobi per mano di Darth Vader.

Il film è molto più introspettivo del precedente e cerca proprio di approfondire la psicologia di Luke, che in Yoda trova una figura saggia e allo stesso tempo scettica, indulgente e severa. Sarà proprio il fantasma di Forza di Obi-Wan a convincere Yoda che vale la pena istruire il ragazzo alle arti Jedi.
Parallelamente, Leia e Han a bordo del Falcon saldano il loro conflittuale rapporto, in fuga dal mercenario Boba Fett e dall’Impero. Tra un combattimento nello spazio e un allenamento di Luke sul pianeta Dagobah, l’atmosfera di questo secondo capitolo raggiunge il suo apice nelle frenetiche sequenze ambientate sulla Città delle Nuvole di Lando Calrissian.

Grazie a un inganno di quest’ultimo, Vader cattura Leila e pietrifica Han in una lastra di grafite, mentre Luke cade nella trappola del misterioso sith. La storia del cinema riconosce il combattimento a colpi di spade laser tra i due come uno dei momenti più celebri in assoluto: la sconfitta di Luke e la rivelazione da parte di Vader sono la tremenda conclusione della fase centrale di una storia capace di tenere i fan col fiato sospeso per tre lunghi anni, fino all’uscita, nel 1983, del capitolo conclusivo, Il Ritorno dello Jedi.
13. Fino all’ultimo respiro (di Elena Matassa)

Gli occhi, la nuca, l’accento di Jean Seberg che interpreta Patricia; il gesto di passarsi il pollice sul labbro che insistentemente compie Michel (citando ironicamente Humphrey Bogart); la splendida carrellata lungo gli Champs-Élysées che accompagna i due protagonisti; le conversazioni nella stanzetta di lei, eccezionali e apparentemente assai poco significative.
Questi e tanti altri sono i lievi e indelebili sigilli che hanno consacrato Fino all’ultimo respiro come film che ha permeato definitivamente il nostro immaginario.
Tuttavia, chi, della mia generazione, ama follemente Fino all’ultimo respiro, forse non sa bene spiegarsi il perché. Un capolavoro come questo ha segnato la storia del cinema in modo talmente irreversibile che non è possibile comprenderlo pienamente senza contemplare il suo significato storico. Eppure, leggerlo “solamente” come il caposaldo del cinema moderno e il manifesto della Nouvelle Vague lo rende forse una pellicola lontana dal presente, leggermente anacronistica.
Al contrario, è tutt’altro che un’opera “accademica”: c’è tanto da cercare ancora in questo film: come tutte le vere opere d’arte esso emana un’aura di significato parzialmente oscura, indecifrabile, impossibile da ridurre a un unico concetto, libera da ogni schema.
In cima alla lista dei motivi che lo rendono (almeno per me) incredibilmente affascinante vi è l’inno alla libertà intessuto nelle varie scene. E ciò è da leggersi almeno in due sensi: come libertà del cinema e libertà del personaggio/individuo.
Libertà del cinema per la rivoluzione sintattica e tecnica che Jean-Luc Godard ha compiuto distruggendo le convenzioni del montaggio, del genere, della sceneggiatura, creando letteralmente un nuovo modo di guardare un film. Un film così libero che nelle scene salienti non succede nulla di rilevante.
Ma il regista libera anche il personaggio facendolo riflettere sul proprio essere prigioniero («Non so se sono infelice perché non sono libera o se non sono libera perché sono infelice» dice una corrucciata Patricia); rendendolo a volte banale e realistico nei dialoghi e nelle scelte; non restituendone un’immagine chiara e definita ma, quasi abbozzando a caso, trattenendo la sua essenza in qualche sguardo o gesto compiuto di sfuggita.
14. Taxi Driver – La voce strozzata della controcultura (di Roberto Valente)

Tutti noi, se pensiamo al nostro legame con il mondo del cinema, abbiamo un film al quale siamo intimamente legati. Per quanto mi riguarda quel film è Taxi Driver, pellicola antesignana della filmografia di Martin Scorsese.
Questo film, distribuito nel 1976 in pieno ricambio generazionale, è iscrivibile (assieme al suo regista) all’interno del processo di affermazione della new wave cinematografica americana degli anni Settanta.
La pellicola affronta tematiche cruciali, specie se considerate alla luce del periodo storico nel quale ha preso vita. In piena guerra fredda, nel 1976, e soprattutto subito dopo gli orribili vent’anni di guerra in Vietnam, il film ci presenta un reduce da quel macabro inferno alle prese con il reinserimento nella società.
Tale società tuttavia era già irrimediabilmente cambiata: si era innescato quel meccanismo di massificazione che attraverso i nuovi media e il loro cinico utilizzo sarebbe diventato l’arido sistema capitalistico, un sistema alienante verso il quale è difficile approcciarsi.
New York è una giungla urbana, una città colma di male, ipocrisia e indifferenza verso il prossimo: tutte caratteristiche che segneranno la già fragile mente di Travis, il nostro protagonista. Egli lavora come tassista, per combattere l’insonnia, e vede il male attraverso i suoi occhi durante le interminabili notti di servizio.
I tentativi di relazione sociale e condivisione di Travis risulteranno goffi e tragici, sintomo di un sentimento di inadeguatezza e profonda solitudine con i quali convive, a suo malgrado, già da parecchio tempo.
A seguito del fallimento dei suoi tentativi di reintegrazione sociale, Travis affronterà faccia a faccia il demone che, in maniera latente, stava facendosi da tempo spazio nella sua psiche. Il risultato di tale confronto e presa di coscienza di una condizione così tragica e spietata porterà Travis a macchiarsi di orribili azioni, le stesse contro cui egli voleva in principio combattere con tutte le sue forze, per dare uno scopo alla sua vita.
15. Il Cacciatore (di Giacomo Taggi)

Il Cacciatore è il capolavoro di un regista, Michael Cimino, che è apparso come una meteora nel firmamento del cinema, lasciando al suo passaggio molte ceneri e una stella immortale: questa.
Un film sulla guerra atipico, che sceglie di raccontarla in modo indiretto, attraverso le sue conseguenze e le cicatrici che lascia dentro all’anima. Un canto aedico in tre atti sull’amicizia virile più profonda e l’impossibilità di salvare una persona da se stessa.
Tre amici, semplici operai della Pennsylvania di origini slave, vengono chiamati al fronte. Si imbarcano per il Vietnam ignari di quello a cui stanno andando incontro, convinti che sarà solo una parentesi e al loro ritorno troveranno tutto come lo hanno lasciato. E in fondo è così: ma sono loro a essere cambiati per sempre. Il più sensibile di loro, Nick, segnato per sempre da ciò che ha visto e vissuto, deciderà di non tornare affatto, e sarà Michael, il suo migliore amico, a tornare in Vietnam una seconda volta per cercarlo.
Il cacciatore che dà il nome alla pellicola è lo stesso Michael, che crede fermamente nell’importanza di una lotta ad armi pari tra lui e la sua preda: poiché il cervo non può difendersi, il cacciatore ha diritto a un solo colpo. Ma in guerra si accorgerà di come ogni ideale sprofondi nel nulla fino a privare di senso la stessa vita umana. Il velo dell’illusione quotidiana viene dissolto. La caccia da rituale sacro, diventa grido di dolore senza risposta e senza possibilità di redenzione. Ogni legame con l’equilibrio della natura è spezzato, e l’uomo è costretto a guardare nell’abisso profondo che improvvisamente si spalanca dentro di lui.
E questo film ci racconta proprio questo: cosa accade quando guardiamo l’abisso in faccia troppo a lungo.
16. Qualcuno volò sul nido del cuculo (di Giammarco Chiellino)

Qualcuno volò sul nido del cuculo, tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey e diretto da Miloš Forman, ha preso vita nel 1975.
Ed è proprio di vita che il film stesso tratta, dell’essenza minima per poterla definire, o anche soltanto riconoscere, nonché degli sforzi che si è disposti a fare per difenderla. Cosa vuol dire vivere davvero? Come si sostanzia empiricamente una vita vissuta ‘appieno’? Ma, soprattutto, cosa ci rende oggettivamente, indiscutibilmente pazzi, malati o incapaci di vivere la nostra, di vita?
Queste le tematiche di un capolavoro che ha stravolto la faccia realista del cinema a esso contemporaneo, portandola alla ribalta: cosa distingue un uomo rinchiuso e per ciò solo folle, da uno rinchiuso propriamente a causa della sua follia? Come discernere tra la pazzia del mondo all’esterno, e quella insita nell’aspirazione di curare internando? In quali sfumature (e questa è la vera domanda) possiamo scorgere la differenza tra anticonformismo quale espressione d’intelletto, creativa quanto costruttiva, e quale strumento di caos, destrutturante quanto distruttivo?
Jack Nicholson, nei panni di Randle McMurphy sembra rispondere, o quanto meno provarci: lui, che accumula sospetti di star soltanto simulando la follia, lui che nel pezzetto di mondo in cui i personaggi sono confinati costruisce una finestra per permettere agli altri di non dimenticarlo mai, quel mondo, di non mettere mai in dubbio che sia lì fuori né tanto meno che un giorno ognuno di loro potrebbe farvi ritorno. Lui, che osa volare sul nido del cuculo e insegnare a essere davvero esseri migratori: mettere radici pur non restando fermi.
Il film, tra gli unici tre nella storia del cinema a aver trionfato in tutte e cinque le categorie principali degli Oscar, è un monito alla riconsiderazione delle nostre capacità quanto dei nostri limiti, dei nostri desideri reconditi così come di quelli che siamo disposti facilmente ad abbandonare in cambio di una confortevole e avvolgente sensazione di sicurezza.
Ancora, soprattutto, è rappresentazione sistematica seppur disturbante di come quella sicurezza spesso stritoli, piuttosto che avvolgere. Rientra a pieno titolo nei migliori secondo la Settima Arte.
17. In the mood for love (di Andrea Vailati)

In un’eterna vita di ricerca, condannata alla pretesa di controllo, il grande paradosso è sempre più visibile: complichiamo ogni cosa, mediando con la ragione, esplicitando con la narrazione, proprio perché incapaci di cogliere proprio la sfuggente, sussurrata semplicità del non detto. Ma la prosa, così bisognosa di dirsi, non è l’unica categoria d’arte che il cinema ha saputo toccare.
Poiché se l’Occidente si è fatto promulgatore, spesso e non sempre, del romanzo cinematografico, l’Oriente, in sguardi sospesi, in emozioni osservabili nell’armonia degli sguardi, ha disegnato sottili linee di poesia a matita. In the mood for love, come un vecchio aedo con la sua arpa, ci canta in versi il mondo creato da due stati d’animo che si intersecano senza mai toccarsi.
Non è una vicenda connotata da i tempi di una realtà narrativamente contenuta. È la poetica dell’eterno forse, sospeso in un sempre e un mai, dove, quasi spiandoli, osserviamo due esseri umani alle prese con la purezza di una possibilità incontaminata dall’atto reale, sempre lì, ferma, così potente e così tenue, dove l’Amore è semplicemente ciò che potrebbe se non fosse davvero.
«Sono io, se ci fosse un biglietto in più, verresti via con me?».
«Sono io, se ci fosse un biglietto in più, mi porteresti via con te?».
(In The Mood For Love)
18. Il Padrino pt. I e II (di Andrea Vailati)

La condizione emblematica di un film è data dal suo farsi canone di una convergenza storico-artistica quanto mai ricca di elementi fondanti. La potenza espressiva di personaggi, interpretati in una forma attoriale a cavallo tra due tempi storici del cinema. L’eleganza osservativa nel ritrarre un’epoca, una realtà, un modus vivendi contaminato eppure così puro, che contrasta un mondo passato, che non conosce che mondo stia costruendo insieme al tempo.
Il Padrino (pt. I e II) è l’applicazione nel cinema di una forma narrativa profondamente totale, nel suo farsi romanzo storico di un’intera mini epoca umana, nel suo stigmatizzare elementi della realtà ancora non canalizzati in una costituzione scritta, ma profondamente ricchi di tratteggi sociali determinanti per il mondo dove esistono.
Il Padrino è un passaggio determinante del cinema, ancora ricolmo di “colossalità”, a un colore moderno, agli arbori del “romanzare”, quando ancora non vi era ridondanza, ma sperimentazione.










