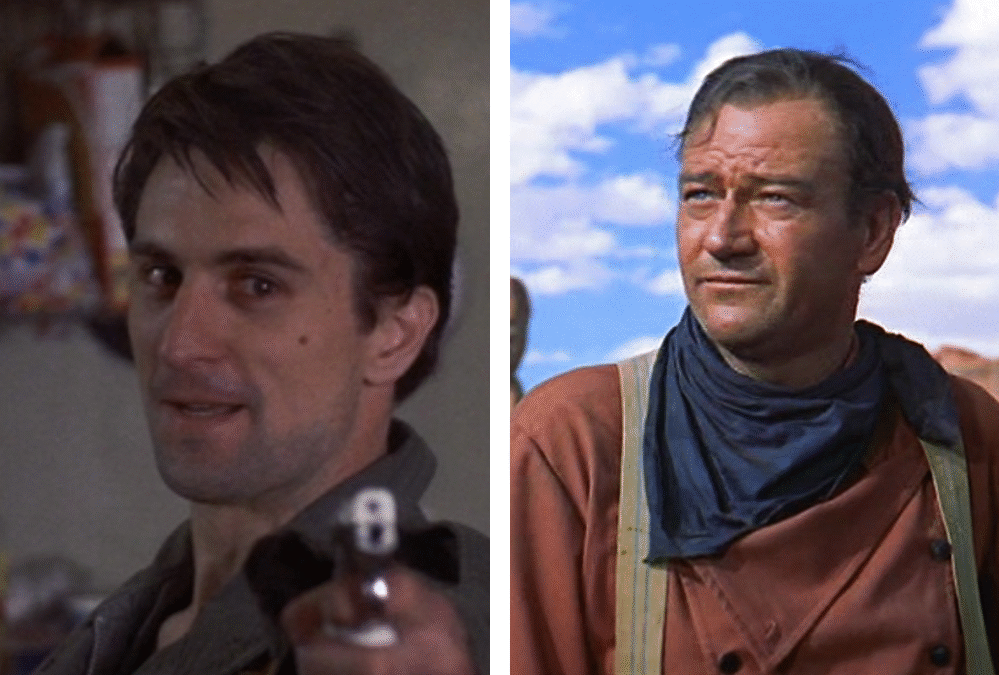Una storia vera: Lynch e l’America perduta
David Lynch è americano.
Contemporaneo di Martin Scorsese, figlio di un tempo in cui il cinema degli Stati Uniti scopriva il neorealismo, Fellini, Sartre e Freud. E Lynch segue una sua linea parallela alla New Hollywood, per qualche verso inedita, per qualche verso irripetibile.
Le sue storie sono pura pittura umana, simboli e archetipi che non vogliono significare altro se non il sentire di un autore e forse di una generazione.
Il sé che si scompone, le paure che si fanno mostri, i valori che si svalutano, i giardini che mostrano i vermi.

Eppure, David Lynch è americano, e quell’America lenta, dalle distese che dialogano con l’immenso, dai sobborghi di famigliole fatte di griglia e feste di paese lui la conosce. Quel respiro continentale e provinciale allo stesso tempo è poco raccontato dagli americani, che tengono a muoversi nelle grandi metropoli o nei non luoghi del West. E Lynch più di tutti ne sembra assai distante. Il suo surrealismo non partecipa a quel tipo di bucolico, di essenziale, di fiabesco, anzi.
Poi, accade.
Arriva una sceneggiatura per Una storia vera, fatta proprio di quell’essenzialità. Il titolo stesso del film è The Straight Story, dritto, essenziale.

Laurens, Iowa. Un anziano uomo riceve una telefonata: il fratello ha avuto un infarto. Non si parlano da una vita, per liti dimenticate e rarefatte nella distanza. Vuole andarlo a trovare prima che sia tardi. Così, non avendo mezzi o grandi disponibilità, parte con il suo trattorino rasaerba.
«Su questa strada non c’è benedetta anima viva. Sono scomparsi tutti tranne me e si sono portati via il mondo.»
(McCarthy, La Strada)
Ed ecco che tutto ciò che il cinema aveva decostruito se stesso torna in una forma ancora più essenziale. Il più semplice dei viaggi, fatto dei più canonici degli appuntamenti narrativi: incontri con l’umanità americana, dalla ragazza incinta scappata di casa al gruppo di ciclisti, passando per la coppia di coniugi delle villette a schiera, due buffi meccanici gemelli e un sacerdote. Tutto è linearità pura, retorica sulla vita, sulle scelte, sull’amore.
Ma non è costruito, bensì ritrovato.

Se la fiaba e la storia canonica, il viaggio dell’eroe e così via si sono perse nelle sovrastrutture mitico-narrative, qui invece si tratta di ritrovare l’autentico dopo aver tolto tutto. Come se distruggendo un palazzo con film che raccontano i frammenti delle impalcature, si ritornasse alle fondamenta, che respirano di quella stessa semplicità che il palazzo voleva rappresentare, ma senza i costrutti fittizi. Senza le morali didascaliche.
Perché non è un idealtipo di America o di società contemporanea che Lynch ci vuole raccontare, ma proprio la sostanza primigenia degli Stati Uniti. Quella fatta dell’immensità che si disperse in semplicità perdute, su cui quei valori si fondavano ma dalle quali l’America si è allontanata.
Così la povertà che gli Stati Uniti avevano riempito di una fiaba fin troppo borghese, diventa l’originalità di una cultura, semplice, nei suoi deliri, nelle sue imperfezioni ma nel suo tentare di vivere, perdonandosi con poche parole, vivendo delle loro piccole storie.
«Che cos’è l’uomo, insomma?
Che cosa sono io?
Che cosa sei tu?»(Walt Whitman, Canto di me stesso)