Green Book – Il ribaltamento del pensiero dicotomico
Nella cultura occidentale predomina da secoli una visione categorica e frammentata della realtà. Parliamo di un immaginario volto a dare un ordine a un mondo caotico e confusionario, che confonde e rende enigmatica la nostra stessa esistenza. Un’analisi risoluta e rigorosa ritrova le sue radici già nella filosofia dell’Antica Grecia: dalla dottrina platonica emerse la contrapposizione tra ciò che è considerato tangibile, concreto e ciò che è considerato intangibile, astratto, ossia il mondo delle idee.
La concezione dualistica ha di fatto instaurato una netta divisione tra corpo e mente, ostacolando il senso di unicità e caratterizzando la cultura occidentale in senso totalizzante. Si immagina la realtà come una sequenza di 0 e 1, matematizzandone la natura, oppure istituendo un giudizio morale nei concetti manichei di bene e male, giusto e sbagliato, vero e falso.
Ci troviamo di fronte a escludere qualsiasi “possibilità terza”, qualsiasi alternativa o via di mezzo. La stessa filosofia aristotelica congetturò l’inesistenza di una soluzione intermedia, riconoscendo una realtà di sole due proposizioni che si escludono a vicenda, seguendo la logica dell’et-et e scagionando categoricamente la prospettiva dell’aut-aut.
Non esistono sfumature e non c’è ambiguità, solo distinzioni rigide e nette che riducono il multiforme a sole due categorie, contrapposte in un inevitabile conflitto perenne. Ed è proprio questa lotta che rende la realtà complessa e disordinata.
Ci viene però in soccorso l’immenso impero mediatico, e così siamo indotti a scegliere, a estremizzare i nostri pensieri. Ma “ l’appoggio” mediatico che sembra volerci facilitare il modus vivendi non è nient’altro che il metodo più efficace per imporci un determinato modus cognitandi, privo di “se” e privo di “ma”. Ci riduciamo ad assorbire uno schema già predisposto, inconsapevoli della nostra autosufficienza cognitiva e portati ad avere una visione passiva e acritica del mondo che ci circonda.
Il pregiudizio che alimenta la visione dualistica della cultura occidentale può essere, tuttavia, contrapposto a una visione del tutto olistica e convergente, rappresentata dalla filosofia orientale. Quest’ultima indebolisce e smonta del tutto la concezione cartesiana che divide la psiche dal corpo, introducendo una nuova logica, tendente a unire e inglobare, ma soprattutto a riconoscere l’esistenza di sfumature.
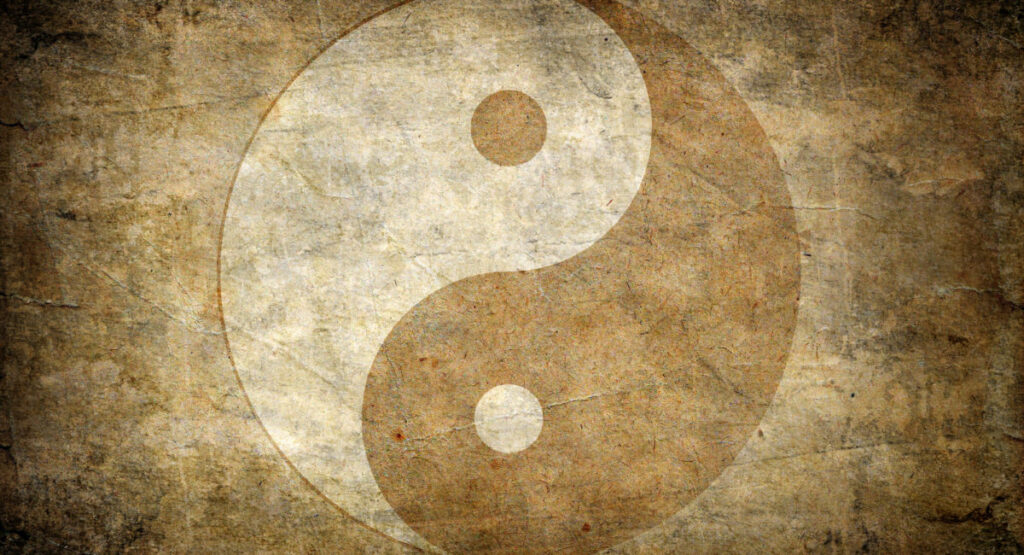
Valicando i confini di una cultura severa e selezionatrice la filosofia orientale è riuscita a rompere la dicotomia del bianco e nero, rappresentando la visione armonica della realtà attraverso il Tai Chi, conosciuto come il simbolo dello Yin e dello Yang. L’emblema salvifico orientale pensa a un mondo in cui è superata la distinzione tra bianco e nero, riconoscendo tra le due entità un legame di equilibrio onnipresente .
Dalla connotazione dogmatica del nero percepito come negativo e il bianco come positivo, attraverso lo Yin e lo Yang avviene una vera e propria rivalutazione del modus cognitandi . Tutto il Cosmo si basa sulla coesistenza di queste due entità interdipendenti e nessuno dei due è completamente Yin o completamente Yang.
Nonostante questa visione alternativa proposta dal pensiero orientale, risulta però difficile appendere sul filo dell’opinabile tutti quei dogmi ai quali ci siamo da sempre affidati. Perché dovremmo rinunciare alla comodità di uno schema dicotomico semplicistico a favore di un nostro sforzo interpretativo ?
Il tentativo di valutare in termini dicotomici ogni nostra scelta volge a demonizzare tutto ciò che si trova al di fuori del rigoroso dualismo, arrestando ogni forma di curiosità. Il timore di uscire fuori dagli schemi convenzionali rende così la mente inflessibile, imprigionata da una paralisi cognitiva.
Se le produzioni culturali sono le prime ad alimentare questa distorsione cognitiva, il film Green Book (2019) rappresenta tra queste l’eccezione. Il regista Peter Farrelly è riuscito a ribaltare cinematograficamente il discorso dicotomico bianco-nero, come analogamente la filosofia orientale ha agito sull’austera ottica occidentale . L’inconsapevolezza della visione dualistica subisce una radicale metamorfosi, consapevolizzando lo spettatore circa la sua influenzabilità e plasmabilità all’interno di una società incredibilmente pregiudizievole.
1962, New York. La segregazione razziale divide, distingue e discrimina tutto ciò che è dissonante, tutto ciò che spaventa, generando lotta e conflitti di ogni genere. In questo agitato contesto newyorkese due personalità opposte si incontrano e intraprendono un viaggio alla volta del Sud del paese , attraverso il quale raggiungeranno una consapevolezza di sé stessi sconosciuta prima di allora, che li condurrà a una relazione basata sulla fiducia e sull’accordo reciproco.
Attraverso l’incontro tra il bianco Frank “Tony Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen), un buttafuori italoamericano del Bronx, pieno di sé, rozzo e in continua lotta con il prossimo e il nero Don Shirley (Mahershala Ali), un pianista afroamericano colto, saggio, ma restio nel concedersi ai piaceri della vita, i due personaggi di Green Book modellano le proprie attitudini, certezze e pregiudizi apparentemente inamovibili.

«Eravamo coscienti di certi cliché , come quello del “bianco salvatore” che salva il nero come di quello del “nero salvatore” che salva il bianco . Siamo stati attenti a non far aderire Green Book né all’uno né all’altro modello. Sì, Tony Lip salva Dr. Shirley da alcuni pericoli terreni, ma Dr. Shirley salva l’anima di Tony Lip, rendendolo una persona migliore».
(Peter Farrelly)
Trattare argomenti così delicati e controversi come quello del razzismo si rivela essere un’impresa, soprattutto nel panorama hollywoodiano, caratterizzato dalla forte impronta occidentalista. Si rischia di cadere nel politicamente corretto, arrivando ad appiattire un messaggio che vuole essere molto più profondo. Nonostante ciò, Green Book riesce a mettere in discussione quegli stereotipi dell’immaginario collettivo dicotomico, azzardando un rovesciamento connotativo tutt’altro che assodato.
La personalità di Frank non rispecchia minimamente, secondo gli schemi stereotipati degli anni ’60 (e non solo) il suo colore di pelle; abbiamo di fronte un uomo che vive nel Bronx, corrompe e scatena risse improvvise, caratteri tipicamente connotati al classico gangster italoamericano o a realtà afroamericane. Diversa è la personalità di Don Shirley, un uomo che, nonostante la pelle scura, incarna un personaggio notevolmente istruito, saggio e ricco, tratti tradizionalmente associati all’uomo bianco.
Tutto ciò ci scardina completamente da quelle convenzioni solide e rigide solidificatesi nel tempo attraverso i media, sconvolgendo le nostre ideologie dicotomiche già a partire dall’inizio del film.
I due personaggi sono l’esemplificazione di due entità apparentemente opposte, contraddistinte dal carattere cromatico evidente, ma che presentano nel profondo del loro io tratti stereotipicamente associati all’altro. I due principi su cui si regge il simbolo Tai Chi portano a una esemplare e realistica analogia con i due protagonisti del film: lo Yin e lo Yang sono opposti, ma non in termini assoluti, niente può essere completamente nero o completamente bianco.
Don Shirley: «Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza bianco, allora dimmi chi diavolo sono io!».

Il principio assolutista derivante dalla visione dicotomica costringe l’uomo a un pensiero binario, composto da distinzioni nette e totalitarie. Nasce una spinta, quasi concitata di darsi una definizione, di appartenere a un determinato gruppo, di schierarsi o da una parte o dall’altra, negando categoricamente qualsiasi via di mezzo, qualsiasi sfumatura possibile. Si manifesta la necessità di darsi un’etichetta sociale.
In Green Book la crisi identitaria che colpisce Don Shirley rappresenta un chiaro sintomo della violenza epistemica occidentale.
L’esigenza di dover essere qualcosa pone il personaggio in una situazione di stallo, di completa confusione. Ma tale squilibrio si può risolvere dando credito alla logica parmenidea secondo la quale l’essere è e non può non essere. Il non essere non esiste, si è sempre parte di qualcosa, nero o bianco che sia.
Ed è per questo che l’eccesso dell’uso del concetto di identità, applicato in particolar modo alle definizioni etniche, ha inevitabilmente delle ricadute negative, facilmente sfociabili in pregiudizio. Rinunciamo dunque al pensiero dicotomico, alla visione categoricamente severa della realtà che, come attesta la storia (soprattutto coloniale), ha condotto a tentativi di supremazia sull’altro. In seguito poi rendiamoci consci dell’esistenza di più colori, delle innumerevoli sfumature presenti nel mondo e della ricchezza che possiamo ricavare da esse.
Può prefigurarsi un’impresa difficile e complessa, ma tentar non nuoce. Green Book ci agevola senza ombra di dubbio attraverso uno sguardo fuori dagli schemi della dicotomia, consapevole che là fuori bianco e nero possono dar vita a un “pensiero grigio”, più critico e flessibile.










