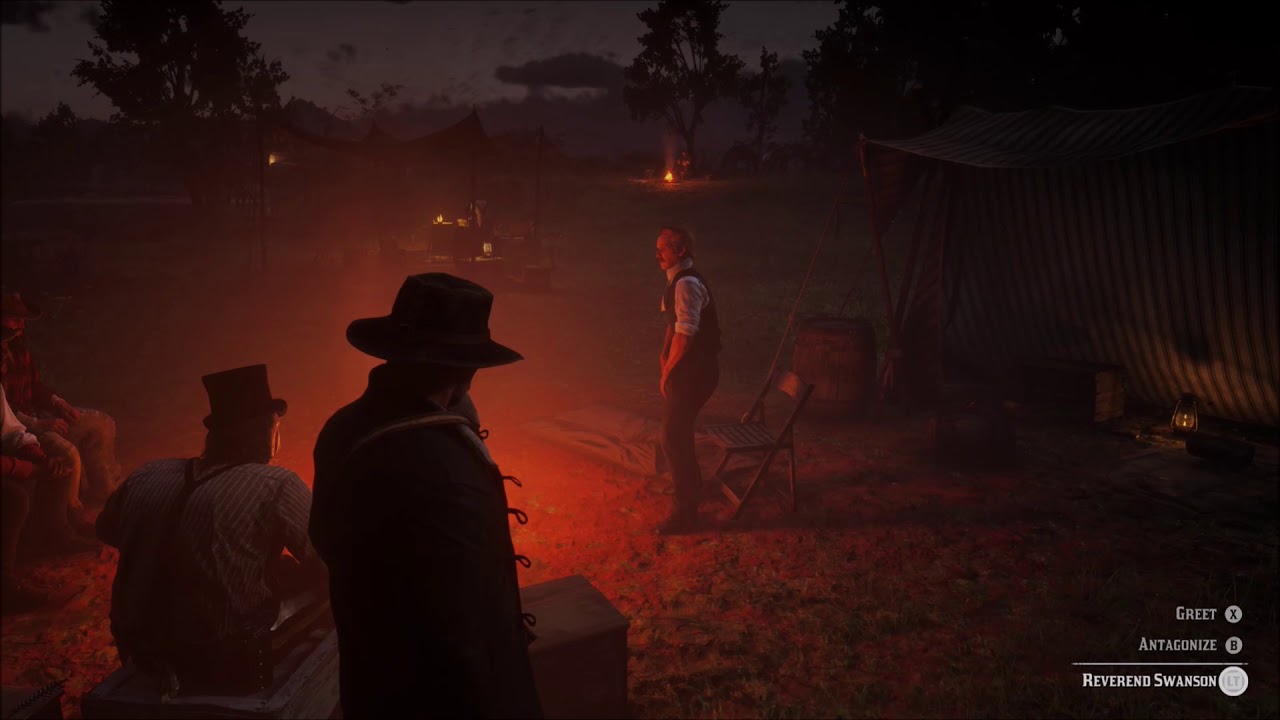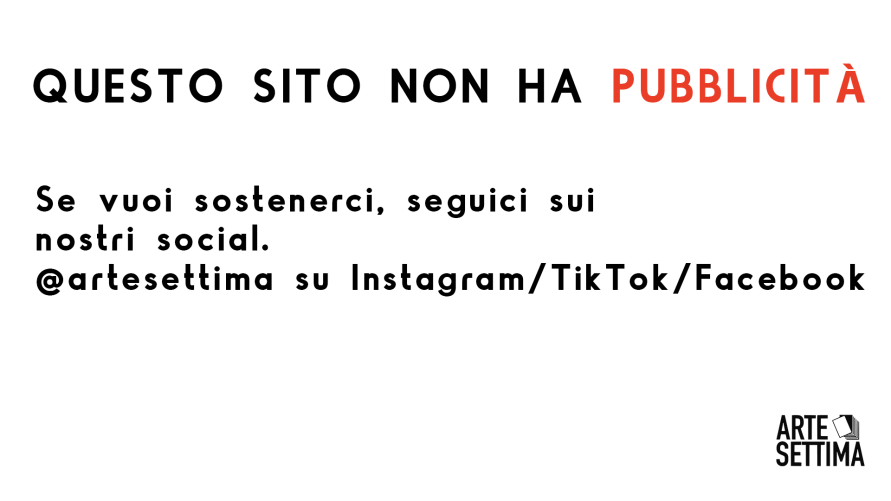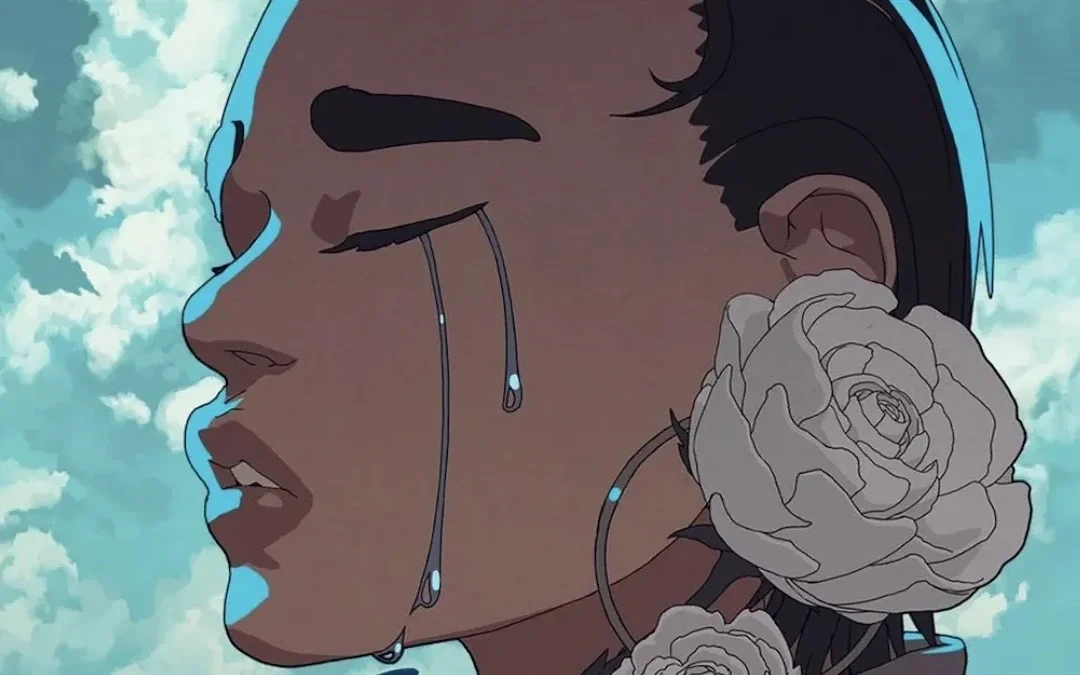Folle. Soverchiante. Megalomane. Titanico. Capolavoro. Eccessivo (no, non si eccede mai questi casi). Di sicuro, il progetto più ambizioso della storia dell’intrattenimento, come lo fu al tempo il suo predecessore.
Red Dead Redemption II e Arthur Morgan spazzano via ogni standard dei videogiochi, il modo con cui si era abituati a guardarli – qualcosa, in fondo, già da tempo presente nei desideri della Rockstar: rendere il gioco non più gioco, ma vero romanzo interattivo, un immenso corpus letterario con una struttura ancor più definita del primo capitolo. Quello, senza nulla togliere a quel gioco straordinario, ad oggi sembra quasi un esperimento, un primo esperimento di una storia che allora non sapevamo essere incompleta.
Il primo raccontava la storia di John Marston e della sue speranza di riscatto, e, attraverso questo, inseriva un enorme spaccato di un’epoca – con mirabili, perfidi allacci al presente.
Nel secondo capitolo si è andati oltre. Non esistono più episodi filler o missioni secondarie. Tutto è principale e fondamentale, tutto è strutturato per immergere il giocatore in un’immensa storia coerente e coesa, con un’unica anima in comunicazione diretta con Keats, Dickens, Zola, come confessato dagli stessi autori – da sempre affascinati e mai intimoriti dal conferire alle loro opere richiami più elevati della media. Ma anche McCarthy, Shakespeare, Melville, Sam Peckinpah, Sergio Leone e John Ford. E non solo.
Proprio qui ci si concentrerà. E’ già stato detto fin troppo sull’epopea di Arthur e della Gang di Van der Linde.
Forse un po’ meno si è detto su cosa possa rappresentare, a prescindere dalla vicenda umana di questo straordinario protagonista, la storia intera nella mente degli autori. E dunque, come sempre, pecchiamo un po’ di superbia e proviamo a scorgere qualche filo rosso in mezzo a questa storia di dure, emozionanti, a tratti commoventi follia e devastazione.
Il mito della caduta
Arthur Morgan è il protagonista di questo secondo capitolo, sicuramente. John Marston, benchè coprotagonista acerbo di ciò che sarà nel primo capitolo, è perciò stesso una presenza fortissima all’interno della storia e uno dei suoi motori portanti.
Ma Red Dead Redemption II è soprattutto la storia di Dutch, appena accennata e ora palese.
La storia del suo inesorabile declino, della sua sconfitta, dello sfacelo della sua famiglia e del sogno di quest’ultima. In fondo, tutta la storia è una grande parabola sulla perdita dell’innocenza, e così non può non tornare in mente il mito della caduta dell’uomo della Genesi.
In quel prologo immerso nel gelo e nella neve, una delle prima missione che ci appare è intitolata “Dopo la Genesi“, forse a segnalarci ancor più questo legame, questo passaggio ineluttabile a cui la banda sembra ormai destinata.
In questo Giardino dell’Eden che la gang rappresenta, fuori dalla grande Storia che incalza col suo peso, i suoi membri paiono vivere in un contesto al di fuori dal tempo, in un mondo ideale a cui aspirano e di cui fanno strenui portavoci e testimoni. Un mondo libero e selvaggio, fuori dagli schemi della società industriale incalzante che, nelle idee di Dutch, non avrebbe fatto altro che schiacciare ancor più i deboli e gli oppressi, ampliando i divari sociali – se a torto o a ragione, col tempo capiremo che le questioni in gioco risultano più sottili e profonde di quanto appaiano, specialmente nella mente dello stesso capo tribù.
In questa interpretazione, Dutch veste insomma i panni del Dio dell’Antico Testamento – spietato e vendicativo, ma premuroso del suo popolo. Un popolo che, nonostante il peccato originale di cui si è macchiato, vede ancora come il suo prediletto, di cui avrà sempre cura.
Quale sarebbe il peccato originale della banda? L’assalto fallito alla banca di Blackwater, evento mai mostrato ma sempre presente nella mente dei protagonisti. Lì, per la prima volta, la banda uccide dei civili, chiedendosi davvero quanto siano diversi dagli altri criminali, come avevano sempre sostenuto; quanto uccidano davvero per prendere ai ricchi e dare ai poveri, e quanto per ferocia o interesse personale.
Da qui in poi, il Dio-Dutch indica ai suoi figli che dovranno iniziare a lavorare sodo e condividere i loro risparmi in una cassa comune, e, per gran parte del tempo, le cose sembrano essere sotto controllo. Esatto, sembrano.
Malgrado le intenzioni iniziali, gli eventi precipitano in maniera lenta e inesorabile. Gran parte dei membri della gang si alienano da quest’ultima abbandonandola, altri iniziano a non concepirla più come la famiglia che avevamo imparato a conoscere, e, a ben vedere, il motivo principale è da attribuire a un solo responsabile all’interno della narrazione.
Micah Bell. Quella lurida serpe, come lo definisce spesso Arthur.
Personaggio straordinario, Micah è demoniaco sotto molti aspetti. Aggregatosi solo di recente alla gang, Micah è caotico, spregiudicato, sadico, privo di alcuna forma di empatia o scrupoli. A differenza degli altri membri della banda, si sa poco e nulla del suo passato, sembra essere stato catapultato lì da un’altra dimensione, completamente diversa rispetto a ogni altro Figlio di Ducth.
Basta ricordare una delle sue frasi più famose: “Io credo che ci siano vincitori e perdenti. Nulla più“, è più che sufficiente a inquadrarlo alla perfezione. Micah è lo spirito selvaggio e demoniaco di sopraffazione che si incunea come un tarlo nella mente di ogni membro della gang, persino e soprattutto in Dutch stesso.
Ha il potere dell’inganno e della lusinga, come solo le grandi personificazioni del demonio possiedono, da Iago a Mefistofele; sfrutta i desideri e le paure degli altri per far breccia nei loro cuori – lo fa con Bill, con Javier, con Dutch, ci prova con Arthur senza riuscirci, ed è proprio per questo che da lì in poi gli si mostrerà sempre ostile, capendo che lui potrà essere l’unico in grado di opporgli resistenza.
E’ lui l’artefice del colpo andato a male di Blackwater, è lui a instillare il germe della corruzione all’interno della famiglia, sotto le sembianze di un frutto maturo e desiderabile. La sua stessa uscita di scena è teatrale e grottesca, allargando le braccia nonostante il cranio fracassato, quasi volesse dire allo spettatore “mi sono divertito abbastanza“.
Mettiamo in pausa questa chiave di lettura, che arriverà, attraverso una nuova fonte, a ulteriori parallelismi.
Bisogna amarlo il fuoco
“Bisogna amarlo, il fuoco. E’ una benedizione. Concessa liberamente a tutti noi. E forse… non liberamente. Mi ricordo di Prometeo. In un certo senso, i miti greci sono i migliori. Ed esprimono tutte le pene che permeano la nostra esistenza con le loro incessanti torture.
Certo, possiamo avere il fuoco! E anche la conoscenza del fuoco! Ma insieme ad essa, arriverà la conoscenza… di ogni altra cosa.
Siamo diventati come Dei. Ma più grande è il potere, più grande è la sofferenza. Sì… Prometeo ci ha dato la luce, il calore, e la dannazione eterna… e la consapevolezza che quanto c’è di sacro ci sarà sempre precluso.”
In una delle innumerevoli scene del campo, il reverendo Swnason pronuncia questo sermone ai presenti. Fu sorprendente scoprire come il discorso cardine del trailer del gioco fosse tratto da una scena in apparenza marginale del gioco. Anche se, a ben vedere, forse sta proprio in quel discorso la vera impronta autoriale che si è voluta dare alla narrazione.
In assonanza col mito del peccato originale della Genesi, nella Teogonia di Esiodo rivestono tale ruolo lo stratificato mito di Prometeo e quello di Pandora, a segnalare la caduta dell’uomo dal suo felice e incosciente stato primordiale a quello della coscienza e della consapevolezza della propria condizione.
In tal senso, Dutch/Zeus spinge gli uomini a lavorare duramente per il loro sostentamento all’inizio della storia, pretendendone una parte come tributo – mentre lui, per quanto ci è dato vedere, sembra operarsi poco o nulla in tal senso. I soldi della cassa comune dovrebbero servire per i bisogni della collettività, ma sappiamo come a un certo punto Dutch, istigato da Micah, e sempre più alienato ai suoi uomini e ad Arthur in particolare, decide di impadronirsene, nascondendola per il bene di tutti in un posto sicuro.
Sta qui, in fondo, la caduta definitiva della banda, la caduta dal suo iniziale, fallace stato di ingenua innocenza.
Come il sacrificio di Mecone segna il primo passo della frattura tra l’uomo e il Divino, così le continue perplessità di Arthur nei confronti di Dutch segneranno un’insanabile e analoga rottura degli equilibri della storia.
Da qui, è facile giocare con le analogie. Se quel John Marston che avevamo imparato ad amare nel gioco precedente, qui è un Epimeteo idiota e ingenuo, cocciuto e quasi sempre incapace di ascoltare i consigli di chi è più saggio e accorto di lui, toccherà a suo fratello tentare di salvare quel poco che è rimasto dalla catastrofe incombente.
Scoprendo l’inganno, la menzogna sottile e inconsapevole che si nascondeva dietro l’utopia di Dutch, Arthur tenterà disperatamente di salvare la gang dalla distruzione, portando loro il fuoco della ragionevolezza, tentando di rendere palese a tutti la deriva che li ha scostati dai loro valori originari.
Come Prometeo, riuscirà in un certo senso nel suo intento, benchè a caro prezzo.
Riuscirà a donare a John e Abigail un futuro diverso, meno felice e utopistico forse, ma senz’altro vero. E’ curioso notare in tal senso come Abigail sia anch’essa origine di numerose dinamiche fondamentali negli sconvolgimenti della gang. Non solo l’iniziale fuga di John, ma anche il cambiamento graduale di quest’ultimo, gli attriti tra Dutch e Arthur nel salvare lei e il piccolo Jack dalla violenza insensata in cui stanno sprofondando, e non per ultimo è colei che convince John che possa esserci per lui, attraverso il duro lavoro, una possibilità di redenzione.
Divertente poi come Abigail sia colei che riesce a ottenere le chiavi del forziere di Dutch, contenente i soldi della banda. Come se, alla stregua di Pandora, fosse la detentrice delle chiavi del Vaso dei Mali, di quell’American Venom che, inesorabilmente, non poteva non portare l’ideale di Dutch alla rovina.
E che, come sappiamo, inculcherà in John la Speme, ultima dea (intesa come Elpìs, come passiva e inutile illusione rimasta fortunatamente all’interno del Vaso) che porterà la sua storia a quel tragico finale.
Salve, mr. Milton
Se il richiamo letterario alla Teogonia è palese, ce n’è almeno un altro più sottile presente all’interno della storia. Gli autori lo “nascondono” con così poca accortezza da rendelo quasi apertamente dichiarato, giocando con la citazione. Andrew Milton è il duro e implacabile membro della Pinkerton che dà la caccia alla gang lungo il corso del gioco. Jim Milton è il nome usato da John quando, una volta lasciata la gang, decide di iniziare la sua nuova vita da mandriano e ripulirsi.
Tale cognome dunque torna sempre all’interno della storia – quando la lascia a causa della morte dell’agente, ritorna subito nelle sembianze di John. Come se gli autori si divertissero a sottolinearlo.
E a ben vedere, i legami tra Red Dead II e il Paradiso perduto di John Milton sono piuttosto evidenti – con i quali ci riallacciamo al paragrafo sul mito della caduta, portandolo a conclusione. E’ forse qui, in queste analogie, che emerge meglio la forza simbolica della ribellione di Dutch e della sua utopia. Dutch, nonostante i suoi difetti, è impossibile da definire semplicisticamente come malvagio: è stimato fortemente dall’intera gang – eccetto Micah, ovviamente -, definendolo come il loro salvatore, la loro ancora di salvezza, o addirittura come l’uomo migliore che conoscono.
Risulta innegabile il parallelismo tra Dutch e la figura miltoniana di Satana.
Entrambi sono in fondo delle figure ambiziose, ribelli, romantiche per certi aspetti, nell’accezione di amanti della libertà. L’intera, celebre arringa infernale di Satana del Primo Libro sulle rive del lago infuocato infernale, potrebbe benissimo essere attribuibile a Dutch, se sostituissimo i riferimenti a Dio con quelli alla civilizzazione dei magnati alla Leviticus Cornwall:
E’ questa la regione, è questo il suolo, il clima
disse allora l’Arcangelo perduto, questa è la sede
che ci tocca avere in cambio del cielo, questa triste oscurità
invece della luce celestiale? Sia pure così, se colui
che ora è sovrano può dire e disporre
che cosa sia giusto; tanto meglio quanto più lontano
da colui che la ragione ha fatto uguale, la forza reso supremo sui suoi uguali.
Addio, campi felici dove la gioia abita eterna! Salve orrori, salve
mondo infernale, e tu, profondissimo inferno,
accogli il nuovo possessore: uno la cui mente
non può mutare secondo tempi e luoghi.
La mente è luogo a se stessa, e in se stessa
Può fare dell’inferno un cielo, del cielo un inferno.
Che cosa importa dove, se sono sempre lo stesso,
e che altro dovrei essere, tutto meno che inferiore
a colui che il tuono ha reso più grande? Qui almeno
saremo liberi; l’Onnipotente non ha creato
questo luogo per invidiarcelo, e non ci caccerà di qui:
qui potremo regnare sicuri, e per mia scelta
regnare è degno di ambizione, anche se all’inferno:
meglio regnare all’inferno che servire in paradiso.
Anche dopo la disfatta di Blackwater, Dutch mostra le stesse qualità che lo avevano sempre caratterizzato, e che hanno sempre caratterizzato Lucifero: coraggio, stoicismo, inflessibilità di spirito, immenso orgoglio, che la sconfitta pare non aver piegato, ma anzi accresciuto. Sembra infatti che la “caduta di Dutch”, a differenza di quella di Lucifero, sia molto più graduale e appena percettibile nel corso della storia, per quanto inevitabile.
E’ come se il passaggio tra l’essere il portatore di luce nelle vite della sua ciurma all’essere una dannata serpe strisciante, coincida col suo graduale avvicinamento al male rappresentato da Micah, che instilla in Dutch soprattutto il valore della vendetta, una delle grandi debolezze di Lucifero. E’ come se in questa visione Micah e Dutch rappresentassero una dicotomia indiscernibile nella genesi del maligno. Quasi a rappresentare, nelle visioni sempre sottilmente pessimistiche targate Rockstar, come anche il migliore degli uomini, se messo nelle condizioni giuste, possa tramutarsi in un tiranno scellerato. E che solo insieme a Micah e ai suoi fidi che insinua nella gang, nelle loro azioni sempre più votate al caos e alla corruzione, Dutch potrà portare alla reale nascita del Pandemonio.
A tal proposito, in quanto vero personaggio tragico della storia, sinistro nella sua grandezza, Dutch richiama fortemente gli archetipi del genere, primo ovviamente Macbeth. In fondo, immensa delizia, non ci si dovrebbe stupire vista la ciclicità che ha portato Shakespeare a pensare in parte a Satana per creare Macbeth (non a caso vi è una citazione a proposito nell’atto IV scena III, dove Malcolm dice a proposito di Macbeth “Gli angeli risplendono, anche se il più luminoso è caduto.“), e Milton a ispirarsi a Macbeth per creare il suo Satana.
Se tuttavia, nel Paradiso perduto, la figura di Satana si oppone ad un Padre tirannico che tuttavia ha a cuore il destino della sua creatura e prevede la venuta del Figlio per porre ammenda al peccato originale, in Red Dead 2 tutto questo non c’è.
Al pari di Satana, Dutch vuole semplicemente rendersi uguale a quelli come Cornwall – nonostante tutti i mascheramenti che attua all’interno della sua psiche e di cui diverrà cosciente solo alla fine della storia. Ma se il Padre a cui Ducth si oppone è davvero rappresentato dai grandi magnati alla Leviticus Cornwall – il cui nome fa riferimento non a caso al libro biblico della stesura della legislazione tra l’uomo e Dio -, qui è evidente la discrepanza tra la visione del Paradiso perduto e quella di Red dead.
In quest’ultimo il Padre è assente, o se è presente non ha minimamente a cuore il destino dell’uomo. E’ una subdola e tirannica figura che non esita a esercitare pressioni sulle forze dell’ordine – coloro che dovrebbero tutelare l’ordine e la giustizia – esclusivamente per i suoi scopi, schiacciando e vessando i deboli e gli oppressi allo stesso modo di un qualsiasi criminale.
La mancanza della figura del Padre, inteso come garante della Provvidenza, si richiama in fondo a tutto il sottoterra culturale che permea la serie di Red Dead circa i legami tra fato e libero arbitrio, dominanti nel primo capitolo ma assolutamente presenti anche in questo secondo.
In un certo senso, se nel primo avevamo avuto come protagonista un uomo dal fato già scritto, qui abbiamo un uomo veramente libero. Arthur Morgan, a differenza di John, pur nella particolarità della sua condizione, è un uomo libero. E’ sempre libero nella sua scelta di immolarsi, come il Figlio, come Prometeo, per salvare quanto di buono crede possa essere rimasto intorno a lui.
E’ indubbio quanto sia forte tuttavia il richiamo alla libertà scellerata tanto idolatrata da Dutch, e resa diabolica da Micah. Lo avvertiamo in ogni piccolo gesto di questo John ancora acerbo, durante l’epilogo. Sta lì, in fondo, uno dei dubbi più importanti che lascia la fine del sogno della Gang van der Linde.
John e Abigail, proprio come Adamo ed Eva, hanno imparato molto su come stare al mondo. Hanno tastato con mano gli influssi di quella vita orrenda e brutale, del controllo, dell’autorità, dell’utopia illusoria e priva di colpa o peccato, e grazie ad Arthur hanno ora imparato a vivere senza di loro. Certo, si potrebbe pensare che un mondo del genere, dove si dovranno guadagnare il pane col sudore della fronte, sia meno felice del mondo libero e selvaggio di Dutch.
Ma se quel che afferma Nietzsche è vero, allora l’ascesa e la caduta di quel sogno rappresentano la miglior situazione a cui potessero aspirare.
Un mondo senza utopia, senza una battaglia elevata da combattere, potrebbe essere visto come un mondo infelice, ma questo è erroneo. Ora sta solo a John e ad Abigail, e a loro soltanto, trovare un senso alla loro battaglia, l’unica battaglia che valga la pena lottare. L’unica battaglia che ogni uomo, magari anche inconsapevolmente, combatte fin dagli albori dell’umanità: la lotta per trovare un significato, quando la vita stessa non potrà mai procurartelo.
E questo è quanto…
La ballata di Arthur Morgan
Sì, è vero, si è detto di tutto su di lui. Ma la tentazione è stata troppo forte. E il titolo del pezzo lo esplicitava apertamente, a ben vedere. Red Dead Redemption II è la storia della caduta di Dutch, sicuramente. Della perdita dell’innocenza della sua gang, certo.
Ma è anche e soprattutto la ballata di Arthur Morgan, racchiusa mirabilmente in May I stand unshaken, la canzone che realmente più di ogni altra racchiude il senso di quest’epopea western.
Nell’immane storia di Red Dead II, dove come dicevamo ogni personaggio ha un suo background alle spalle corposo e meritevole di attenzione, ci concentreremo dunque solo sulla storia del nostro protagonista, riallacciandoci definitivamente al titolo del post.
Arthur è un protagonista unico del panorama Rockstar. John Martson lo era stato anche a suo modo, come abbiamo ampiamente già discusso in un precedente post. E così anche Cole Phelps, che nella sua immane intelligenza, quasi come Amleto, si trasforma in un patetico ingenuo.
Loro due ci colpivano, poichè fuori dal coro, ma anche i vari CJ o Tommy Vercetti erano delle macchiette tali da risultare simpatici nel loro essere canaglie.
In Arthur questa partecipazione è del tutto assente. E’ questa la cosa che più stupisce di lui.
Non sono tanto i suoi atteggiamenti da mascolino bullo di quartiere, i suoi continui borbottii sarcastici e le sue taglienti, centellinate frasi con minacce e provocazioni più o meno esplicite. Per dirla alla Dennis Lehane, Arthur è una creatura di silenzi. Di silenzi in cui avverti possa esserci un significato, specie rammentando eventuali parole appena pronunciate, ma tutto ciò svanisce non appena passa all’azione, con la camicia all’avambraccio e quel sorriso beffardo e sardonico sul volto.
Dà l’impressione davvero di essere scolpito con l’accetta, ostile e spigoloso, privo di profondità, un oggetto che forse ha davvero ben poco da dire, e lì non può che tornare la memoria a John e ai bei tempi andati – specie vedendolo aggirarsi come un ragazzino imbecille nel campo, maledizione!
Si va comunque avanti, magari chissà, arriverà qualche sorpresa – almeno lo si spera.
E’ impossibile non provare un po’ di sottile antipatia per Arthur quando, istigato da Strauss, cerca di convincere la famiglia Downes a pagare i loro debiti, picchiando selvaggiamente a morte il tisico Thomas e tornando qualche giorno più tardi per la caparra. Tutto sempre con la stessa espressione, senza empatia nè disprezzo per il suo prossimo, senza un palpito, eccetto qualche sottile atteggiamento irridente in modo quasi ostentato. Ci sembra davvero un personaggio piatto, incapace di provare rimorso o di riflettere sulle proprie azioni: senz’altro scopo se non quello di seguire Dutch e i suoi ordini, privo di qualsiasi complessità o moto interiore.
Poi emerge un dettaglio (per l’appunto!). Battutaccia.
Non solo in come tratta i Downes, ma gran parte delle persone con cui entra in contatto, specie se più deboli di lui, ci pare quasi di scorgere in Arthur una sorta di rabbia repressa. Un sentimento che non trova spazio nel suo essere al campo, ma che ha libero sfogo nel suo agire al di fuori di esso.
Non è molto, certo, ma è già qualcosa. Proviamo a scavare ancora, non ci resta altro da fare.
L’interazione coi diversi membri della gang – resa magistralmente a livelli inconcepibili sino adesso da qualsiasi altro videogioco -, ci permette in parte di ricrederci sul nostro protagonista, almeno sulla sua mancanza di spessore. E’ indubbiamente un uomo leale a Dutch e alla gang, per la quale sarebbe disposto a uccidere e ad essere ucciso, su questo avevamo già avuto qualche idea. Ma capiamo come il suo attaccamento sia ben più viscerale del già forte senso di appartenenza di Hosea, Bill o Javier.
Arthur è un vero figlio di Dutch, proprio come lo è stato John. Anche a lui Dutch ha insegnato a leggere e a scrivere, e a tal proposito scopriamo che tiene anche un diario in cui annota praticamente di tutto, come fosse un suo confessionale.
Qualcosa di insolito per un personaggio simile – o meglio, per l’idea che ci siamo fatti di lui.
E’ proprio in questo diario, e nelle interazioni con gli altri personaggio, specialmente femminili, che capiamo finalmente qualcosa in più di lui oltre quella barriera che ci aveva posto di fronte. Scopriamo che anche lui stesso si definisce una persona cattiva, senza alcun possibile sottotesto guappo: Arthur sembra essere dispiaciuto in alcune occasioni per la sofferenza e la distruzione che lo circondano e che anche lui contribuisce a causare. Come se in lui si agitasse una forza misteriosa che anela alla violenza e al sopruso. Come se, parole sue, a volte sentisse di non avere il pieno controllo di sè e delle sue azioni.
Arthur in fondo, lo scopriamo solo pienamente da metà del gioco in poi, desidera una vita diversa, magari inconsapevolmente, o magari desidererebbe essere una persona diversa. Lo intuiamo tra le pagine del suo diario, da come descrive quelli come Charles o Lenny, quei membri della banda a cui sembra quasi naturale essere onesti, altruisti, che a differenza sua gli appaiono nati per comportarsi rettamente. Lo intuiamo quando porta il piccolo Jack a pescare, lo intuiamo con Mary, il suo eterno amore mai pienamente realizzatosi, e in tantissime altre situazioni che lo invischiano i suoi compagni e fratelli, perchè sì, è questo che sono per lui: tutta la sua famiglia.
Più tardi, in una scena capitale del gioco, Arthur si confesserà per la prima volta – non solo con la vecchia suora messicana, ma anche, in un certo senso, a noi. Confessa di avere avuto una moglie e un figlio che sono morti, di avere avuto un padre malandrino morto quand’era ancora un bambino e che “non è morto abbastanza presto” (e di cui tuttavia conserva una foto, di cui tuttavia porta tutt’ora il cappello).
Capiamo dunque che Arthur è un personaggio straordinariamente contorto e sfaccettato, pieno di conflitti e inibizioni, sempre racchiusi nei suoi silenzi e nei suoi sguardi. Straordinariamente umano.
E capiamo dunque cosa significhi questa nuova famiglia di reietti emarginati per cui sarebbe disposto a dare tutto: una sorta di seconda possibilità, di seconda famiglia che stavolta non ha intenzione di perdere. Basta dunque una spinta, a questo personaggio meno statico e granitico di quanto credevamo, per riuscire a far crollare ogni sua convinzione. Una spinta per nulla leggera oltretutto.
Inizialmente non ci si fa quasi caso, passano assolutamente in sordina quei colpi di tosse, ma dopo la cacciata sul (o dal) Paradiso, a Guarma, finalmente capiamo che qualcosa non va. La visuale sfuocata, le immagini che si accavallano in una dimensione quasi onirica, ultrasensibile. Sappiamo già cosa lo aspetta, prim’ancora che il medico gli dica il responso. Del resto, del buon Arthur – ci si concede di chiamarlo così, a ben vedere – non c’è alcuna traccia nel primo capitolo.
Tubercolosi. Il dottore gli consiglia di restare al caldo e all’asciutto nel poco tempo che gli rimane. Una raccomandazione a cui reagisce con un sarcasmo che risulta già diverso, che sentiamo più vicino, forse non sappiamo bene neanche perchè.
“Come le ho detto: mi dispiace per lei, figliolo. E’ davvero una brutta faccenda.”
Si alza e se ne va. Da solo con se stesso, come sempre. Con quel limite ormai ben visibile, palese ai suoi occhi. Col peso delle parole di un passato impossibile da cancellare. Di una vita orrenda e sbagliata, impossibile da perdonare.
Un cervo o un lupo, ognuno di loro farà la sua comparsa a questo punto – il cervo simbolo cristiano di rinascita, e quindi in parte associato alla Resurrezione, il lupo di crudeltà ed egoismo vorace e senza freni. Quasi a mettere Arthur di fronte alla vera natura della sua anima – benchè, come spesso Arthur confessa: “Non riesco comunque mai a credere in nulla.”
Sale a cavallo dopo questi pensieri e visioni disturbanti, e se l’affinità con la bestia è abbastanza alta, si avvicina all’orecchio della bestia e sussurra “Remember me, boy”.
Come se quel suo fido compagno potesse rappresentare una seppur minima speranza di lasciare qualcosa di buono nel mondo, una seppur minima traccia positiva del suo passaggio.
Un evento di importanza capitale, il maggiore senza ombra di dubbio, che spazza via ogni cosa. Arthur sa che il suo percorso è ormai agli sgoccioli, che non gli resta più alcuna forma di progetto nella sua vita, e inizia a riflettere su quest’ultima in silenzio, tacito come è sempre stato. Racconta a pochissimi della sua malattia, e solo sotto esplicita richiesta, continua a svolgere le sue funzioni nella banda come sempre, solo riscontrandone ormai le innegabili contraddizioni, la deriva che ha preso giorno dopo giorno e che, a conti fatti, sta portando lui stesso alla morte.
E’ stato infatti, come Arthur realizzerà scrivendolo nel suo diario, il signor Thomas Downes ad averlo infettato, mentre lui lo picchiava selvaggiamente per riscuotere il debito contratto.
Tutti quei proiettili che mi hanno sparato contro, e i cavalli e le risse, e alla fine sarà il pestaggio del piccolo, patetico signor Downes ad uccidermi.
Da lì in poi il percorso di Arthur cambia registro, tutto in virtù delle nostre scelte. Vi saranno sempre un’infinità di missioni opzionali (mai filler, nè secondarie, come già detto), ma in cui ora avremo l’opzione di segnare il percorso da dare a quest’uomo al tramonto, ormai condannato. Condannato, già lo sappiamo, a una morte per nulla eroica e onorevole, ma di consunzione e disfacimento lento e inesorabile. Una morte vera, e autentica.
Dopo la malattia insomma, per la prima volta, potremo decidere realmente del suo destino, di non accettare compensi dagli sconosciuti, di poter agire con rettitudine o meno, come se le catene di quella vita precedente avessero perso ogni importanza di fronte al destino che lo attende.
Paradossalmente la tubercolosi rende Arthur un uomo libero, nel vero senso della parola come confesserà a Mary-Beth.
A prescindere dalle decisioni che prenderemo in questo percorso di maturazione unico, Arthur sembra agire con una leggerezza e una saggezza rinnovate, con un acume sottile di cui sembrava sprovvisto all’inizio del gioco. Non è una questione di versione buona o cattiva di Arthur secondo chi scrive, questione su cui si sono arrovellati molti giocatori, spesso in modo sterile, tirando le somme del suo percorso.
Arthur Morgan è un solo personaggio, con una sua psicologia ben definita, desideroso di cambiare, di avere una vita diversa, di essere un uomo diverso, questo è un fatto assodato. Che riesca o meno a raggiungere questo obiettivo, almeno in parte, ciò sarà in mano esclusivamente a noi.
Focale in tal senso è il personaggio di Pioggia Che Cade, in un dialogo di importanza capitale (sì, tutte queste scene hanno importanza capitale!) in cui espone il senso della pace in un mondo di devastazione e follia:
Mio figlio ritiene ci sia gloria nella morte. Forse ha ragione. Ma per quanto mi riguarda, ho visto così tanta morte provocata dai più stupidi degli uomini, che non potrei mai associarla alla gloria. La gloria sta nell’aiutare gli altri. Forse… o forse no, non so dirlo.
Queste parole lasciano un segno. Lo notiamo subito dallo sguardo di Arthur, perchè ormai la nostra empatia con lui è totale. Ogni barriera che lui poneva tra sè e il mondo, tra noi e lui, è cessata da tempo, sgretolandosi pezzo a pezzo. Lo conosciamo ormai in ogni suo aspetto, quanto se non più di chiunque altro dietro i suoi muri di silenzi. E’ come se Arthur, in verità, fossimo noi stessi.
Anche le missioni principali hanno sempre più derive opzionali nel post-TBC, totalmente in mano al giocatore. Anche qui, sta a noi scegliere quanto Arthur riuscirà nel suo intento di trasformarsi in una persona migliore.
E in ogni caso, tutti i fili convergeranno lì infine, in quell’ultima cavalcata, in quell’ultima corsa contro il tempo per dare un briciolo di senso a una vita.
Una corsa che, nonostante l’amarezza che solo chi ha giocato al primo capitolo può avvertire in quel finale così gioioso ai limiti dell’irridente, lascerà comunque un qualcosa di certo. Che la storia di Arthur, nel bene o nel male, può ritenersi conclusa, così come la storia del giocatore, divenute ormai inscindibili. Come se quell’empatia tanto impossibile all’inizio della storia e ora viscerale, ci possa dire qualcosa di più su di noi, come solo le migliori opere narrative sanno fare. Dopo le quali sai di non essere più lo stesso.
Sta solo a noi dunque decidere se Arthur, alla fine dei giochi, si renderà conto che quella Redenzione sia qualcosa di irraggiungibile per un uomo come lui. O se – sacrificando tutto se stesso come Gesù, come Prometeo, alle prime luci di un’alba spietata, indifferente, meravigliosa – riuscirà in quell’ultimo respiro salvifico, in quell’ultimo sguardo di Orrore, a rendersi conto che nonostante tutto, non è stato poi una persona così terribile.
Hosea: E tu, Arthur? Come vorresti morire?
Arthur: Ah, non mi interessano molto queste sciocchezze.
Hosea: Dai, forza!
Arthur: Bhe… con lo sguardo ad Ovest. Così potrò vedere il sole al tramonto. E ricordare tutti i bei momenti che abbiamo vissuto.
Hosea: … Hai visto, Tilly? Te l’ho detto che Arthur ha un’anima.