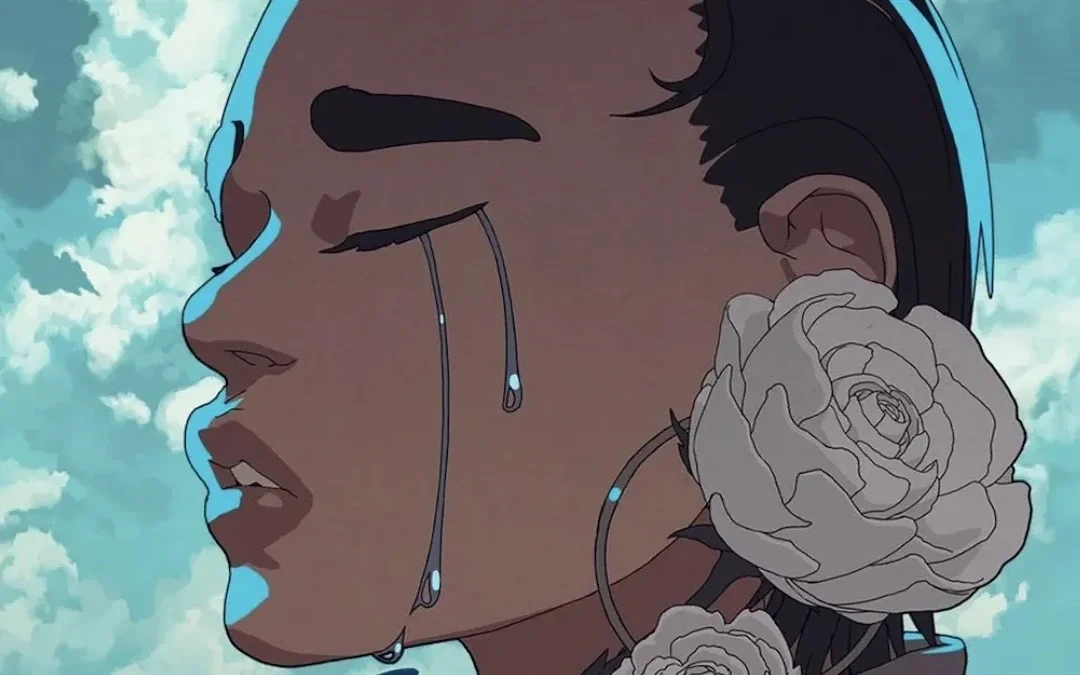Cosa hanno in comune l’Enrico IV pirandelliano e Marcello Mastroianni? All’apparenza nulla. Ma basta approcciarsi alla versione che Marco Bellocchio dà del personaggio per comprendere che l’attore è perfetto per la parte.
Il regista si è confrontato spesso con opere teatrali o letterarie, trasformandole e rendendole portavoce delle proprie idee e visioni. E, nel 1984, gira Enrico IV, il cui stravolgimento è legato, principalmente, alla lettura del protagonista.
Dopo un periodo piuttosto altalenante della sua carriera, Bellocchio inizia a interrogarsi sull’importanza del ruolo dell’attore. Dirigendosi, in maniera quasi naturale, verso l’opera pirandelliana che, per prima, inizia a scardinare il concetto stesso di attore e tragedia. È nel 1921, infatti, che lo scrittore comincia ad allontanarsi dall’idea del personaggio, iniziando a creare protagonisti sempre più sfaccettati e meno imbrigliati in precise caratteristiche.
Il confronto/scontro fra maschera e persona raggiunge quindi nell’Enrico IV massimi livelli di lucidità e chiarezza.
Un uomo, in seguito a una caduta da cavallo avvenuta durante una parata in costume, impazzisce. Il trauma, infatti, lo porta a credere di essere realmente il personaggio storico di cui vestiva i panni. Alla parata partecipano anche la sua amata Matilde Spina e il suo rivale in amore Belcredi. Ad assecondare la sua follia ci pensa il nipote, il quale ricostruisce, nel palazzo dove vive l’uomo, la reggia di Enrico IV. Dopo circa dodici anni, l’uomo rinsavisce improvvisamente. Incapace di riprendere le fila della propria vita, decide di continuare a fingere la pazzia.
La vicenda rappresentata inizia vent’anni dopo, quando il nipote, Matilde Spina, sua figlia Frida e Belcredi si recano a far visita a Enrico insieme a uno psichiatra. Nel tentativo di guarirlo, il medico suggerisce di ricostruire la scena della cavalcata. Frida vestirà i panni della madre. In uno slancio di passione, convinto che si tratti del suo antico amore, il protagonista tenterà di abbracciarla. Belcredi però si opporrà, finendo con l’essere ucciso dall’uomo. Per non assumersi la responsabilità del suo gesto, Enrico deciderà di vivere per sempre da pazzo.

Frida, interpretata dalla stessa attrice che presta il volto anche a Matilde da giovane, Latou Chardons.
La tragedia, quindi, – caso più unico che raro nella bibliografia di Pirandello – si costruisce intorno a un’unica figura e alla sua presenza\assenza.
Enrico comparirà in scena per la prima volta a metà dell’atto I. Sarà solo nell’atto III che il protagonista apparirà ad apertura di sipario. Ma il suo arrivo è sempre preparato dai discorsi degli altri personaggi, che parlano e ragionano in sua funzione, chiedendosi continuamente quando piomberà sulla scena.
Prioritaria, nell’opera, è la parola. Parola che si incarna nel personaggio di Enrico IV e che si nutre della mancanza di intreccio per prendere possesso dell’intera rappresentazione. Non c’è azione, ma un unico e lunghissimo ragionamento sillogistico, in cui il protagonista finge, ragiona ed espone la sua reale intenzione e condizione:
«E allora, dottore, vedete se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia! – preferii restar pazzo – trovando qua tutto pronto e disposto per questa delizia di nuovo genere: viverla – con la mia più lucida coscienza – la mia pazzia […] Il guajo è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla, la vostra pazzia […]».
(Luigi Pirandello, “Enrico IV”)
In un’opera cinematografica questa priorità della parola si perde a scapito dell’azione. Bellocchio decide, quindi, di creare un Enrico IV privato, che possa entrare in scena ogni qual volta ci sia la necessità.
Vedere come si muove e come si comporta il protagonista dietro le quinte diventa un’esigenza fondamentale e, mentre a teatro non ci interessava minimamente conoscere il protagonista – letto semplicemente come momento di realizzazione di quanto detto dagli altri personaggi – al cinema entrare in intimità con quest’uomo diviene l’unico modo possibile per comprendere l’interpretazione di Bellocchio. Non a caso il personaggio filmico viene ripreso per la prima volta fra le coperte, in una dimensione del tutto domestica e intima. Ben lontana dall’ufficialità dell’entrata in scena di Enrico a teatro, vestito degli abiti della messinscena e già recitante la pazzia.
Il protagonista del film, infatti, diviene una sorta di alter ego della versione teatrale: un uomo comune, tinto di una follia familiare e infantile, insita in tutti noi.
Se letta in quest’ottica la scelta di Marcello Mastroianni non solo viene legittimata, ma diventa l’unica possibile.
L’attore fa del suo stile il suo punto di forza e lo riversa in un personaggio divenuto vicinissimo alle sue corde: il suo carattere pacato, la sua recitazione fatta di silenzi e non di grandi declamazioni – elementi che dalla critica vennero letti come negativi – sono infatti i punti fondamentali della versione del personaggio nella visione di Marco Bellocchio.
Inoltre Mastroianni, in maniera analoga a Enrico IV, riesce anche a giocare con la propria immagine, aiutato in questo da alcuni cambi di trama. La vicenda, infatti, si sposta dagli anni ’20 agli anni ’80 e, di conseguenza, la parata avviene negli anni ’60. Decennio che il regista può ricostruire attraverso ricordi di gioventù, ma che permette anche di richiamare nella mente degli spettatori uno dei momenti più floridi della carriera di Marcello. E, a coronare questo cortocircuito temporale, contribuisce la colonna sonora scelta per la festa post parata, nella quale spicca il celebre cha cha cha de La dolce vita, pellicola indissolubilmente legata al suo protagonista, divenutone una vera e propria icona.

La dolce vita – Marcello Mastroianni.
E questo non prendersi troppo sul serio – tanto dell’attore quanto del personaggio – diviene fondamentale per mettere in evidenza altre due caratteristiche dell’Enrico cinematografico: la maggiore consapevolezza e il carattere fortemente comico.
Il protagonista, infatti, diviene più cosciente della sua scelta. Non si rinchiude nella sua follia solo per sfuggire a una vita che non sarebbe in grado di vivere tra le ipocrisie e le falsità tipiche della classe borghese. Rivendica questa sua scelta: diviene un anticonformista e un alienato, che decide volontariamente di rimanere folle anche quando avrebbe una via di fuga. Nel finale del film, infatti, non avviene l’omicidio di Belcredi, ma il suo semplice ferimento con una spada finta.
Non c’è quindi nessun motivo che costringe Enrico a continuare a recitare: ma lui decide di farlo, sempre più convinto che per lui sia l’unica vita possibile.
Per quanto riguarda il secondo aspetto – la comicità – l’attore può contare su alcune trovate dello stesso regista, che lui usa e sfrutta per fare suo, ancora una volta, il personaggio: una su tutte, l’apparizione in scena con un paio di occhiali da sole, come a volersi fare beffa della trovata dello psicanalista attuata per guarirlo. Il dottore, infatti, aveva suggerito di accendere tutte insieme le lampadine del castello per rafforzare l’effetto del controtrauma.
Espedienti comici, ma che nascondono anche un velo di amarezza, una sorta di latente tristezza di chi è consapevole di dover fingere per tutta la vita e che cerca in questi piccoli lazzi una via di fuga. E irridere gli altri sembra essere l’unica via possibile per rendere più leggera la propria follia.

Enrico IV (Marcello Mastroianni).
Il nostro “eroe”, però, non può permettersi una ricaduta nell’innocenza perduta perché più che la pazzia in sé a lui interessa quello che può ottenere rimanendo ancorato al personaggio storico.
L’interpretazione che Bellocchio dà del protagonista diviene quindi l’elemento cardine della riscrittura della tragedia, veicolata attraverso il cambiamento di paradigma dalla follia alla finzione. Per il regista, infatti, l’opera tratta della necessità di indossare una maschera per poter sopravvivere e per salvare sé stessi dalla sconfitta totale.
È nel finale che le differenze di visione dei due artisti divengono palesi: l’epilogo della pellicola viene modificato per dare una maggiore coesione d’insieme a questa nuova lettura.
Come accennato, nella versione filmica non avviene l’uccisione di Belcredi, ma il suo semplice ferimento. Enrico, quindi, non dovrebbe affrontare le pesanti conseguenze che deriverebbero da un’accusa di omicidio. Decide di continuare a fingere la pazzia non per una scelta di comodo, ma per una scelta di vita. Il regista sancisce in questo modo la parabola del suo protagonista, alienato e incapace di tornare alla quotidianità. Rifugiatosi nella follia dopo essere guarito, continua a rivendicarla e la sceglie anche quando potrebbe rientrare nella società, essendo ormai evidente a tutti che finge da molto tempo.
Dal suo punto di vista, quindi, la sua è una scelta obbligata: meglio una follia sincera e autentica, di cui si può essere sia attori che registi, che una follia nascosta, imbrigliata negli schemi della società “normale”, schemi dai quali lui è escluso da ben vent’anni e che non sarebbe in grado né vorrebbe affrontare.

Enrico IV cerca di nascondere i segni del tempo col trucco e tingendosi i capelli, rimanendo così ancorato alla sua immagine di vent’anni prima.
In Pirandello le motivazioni che lo spingono a reiterare la recita sono analoghe, ma il processo che porta Enrico a doverlo fare è ben diverso. Nel testo teatrale l’uccisione avviene e il protagonista non può far altro che continuare a fingersi pazzo con il beneplacito di amici e parenti. Il suo sembra quasi un gesto di vendetta, compiuto in un momento d’ira. La sua scelta, anche qui obbligata, è la conseguenza di questo atto. Non la causa.
Nel film, invece, il ferimento diviene la causa, l’espediente che consente a Enrico di “rimanere” folle. Senza questo gesto palese e plateale non avrebbe avuto motivi apparenti per rimanere nella Reggia.
Una scelta consapevole, l’ultimo atto del folle ragionatore bellocchiano.