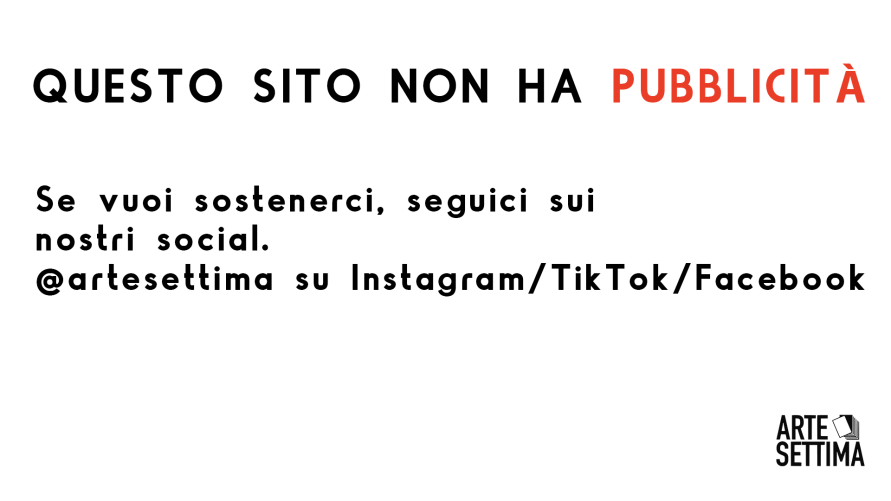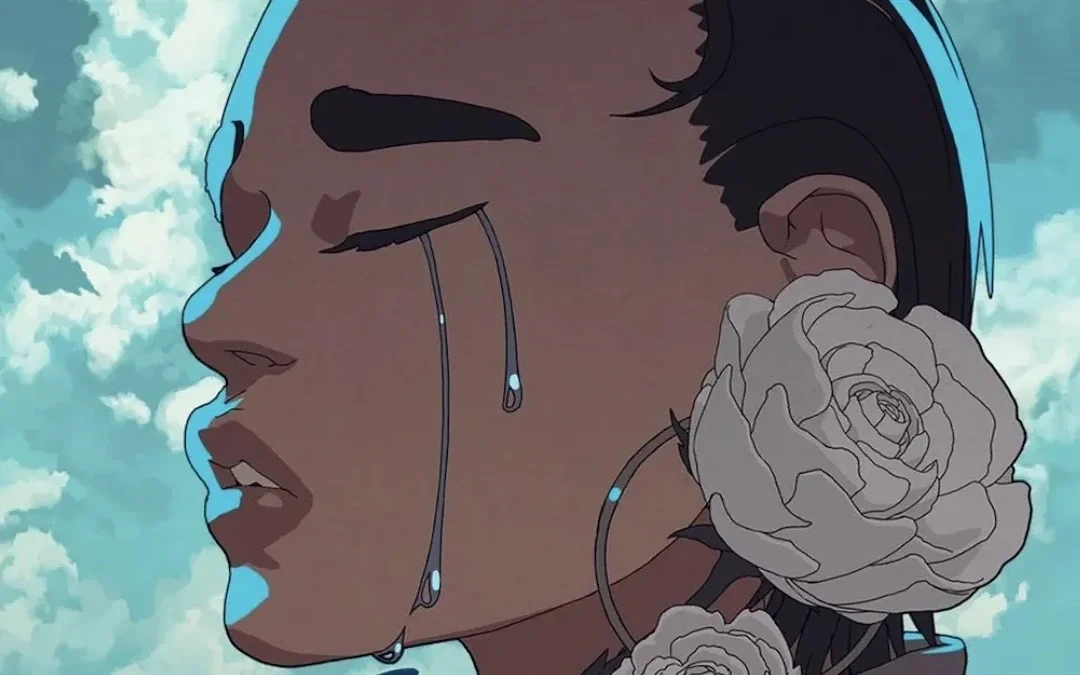Cosa spinge un affermato regista e una nota casa di produzione (Taodue) a trattare di un caso di cronaca italiana fra i più delicati, dibattuti e controversi degli ultimi dieci anni? La domanda – seguita poi da moltissime altre nel corso della visione – sorge spontanea nel momento in cui ci si approccia all’ultima fatica di Marco Tullio Giordana – Yara – dedicato proprio alla scomparsa della ragazzina di tredici anni da cui la pellicola trae il titolo.
Yara: basta il nome, nella sua semplicità, a evocare ricordi nella mente dello spettatore. Sono moltissime le tragedie che passano ogni giorno sugli schermi televisivi. Ma solo pochissime rimangono impresse nella mente a lungo, a causa della loro crudeltà, ma soprattutto perché contengono elementi tali da far in modo che la stampa le scelga fra il troppo numeroso mucchio per farne dei casi mediatici “esemplari”.
Riportate, interpretate, sviscerate fin nei più piccoli dettagli: entriamo nelle case delle vittime, nel dolore dei familiari, nelle minuziose indagini, impariamo i nomi dei protagonisti della vicenda, ci riempiamo la bocca di parole scientifiche o legali che fino a poco tempo prima nemmeno conoscevamo nel loro pieno significato. E, alla fine, sentiamo che quella tragedia ci appartiene, piantata in una memoria collettiva in grado di affiorare al sentir pronunciare solamente un nome: Chiara, Meredith, Sarah, Yara, il piccolo Samuele. E, accanto, i loro presunti carnefici, spesso parenti o amici.
Accade poi che, fra questa rosa così selezionata dai media, siano scelti dei casi in particolare, ritenuti in grado di poter fare il passo successivo: diventare storie attraverso documentari o film di finzione.
Ed è ciò che accaduto alla vicenda di Yara, divenuta dapprima una serie documentaria – Ignoto 1: Yara, DNA di un’indagine – e infine il film di Marco Tullio Giordana, distribuito in sale selezionate per poi essere fagocitato nel catalogo Netflix, confondendosi fra le milioni di storie true crime che compongono l’offerta della piattaforma.
Perché la vita della piccola ragazzina di Brembate sia stata in grado di catalizzare l’attenzione della stampa prima e del cinema poi è presto detto: giovane promessa della ginnastica ritmica, figlia di un paesino in cui non era mai accaduto nulla di così efferato, data per dispersa per tre mesi, – nei quali la vicenda è stata sempre più alimentata – e poi ritrovata morta assiderata, ferita nel corpo e nello spirito da un uomo che verrà poi identificato grazie alle più sofisticate tecniche scientifiche. Il regista, come gran parte dell’opinione pubblica, sarà rimasto folgorato da questo episodio, tanto da decidere di trasformarlo nella trama della sua ultima pellicola.
La scelta di un caso così particolare e conosciuto, però, se da una parte ha permesso a Yara di essere un prodotto immediatamente identificabile per il suo contenuto, dall’altra lo ha reso simile a tantissimi altri progetti. Ciò che manca, infatti, è innanzitutto un taglio registico o stilistico ben preciso.
Tullio Giordana ci ha abituati ad affreschi meravigliosi della storia italiana recente e di vite di personaggi realmente esistiti, nei quali ha sempre inserito la sua personale visione – basti pensare a La meglio gioventù, I cento passi, Romanzo di una strage. Qui, invece, si è limitato a raccontare.

La pellicola inizia con il ritrovamento del corpo di Yara in maniera del tutto casuale a Chignolo d’Isola, distante circa dieci chilometri da Brembate di Sopra. Segue poi la ricostruzione pedissequa di ciò che è accaduto, delle indagini, dei vicoli ciechi intrapresi, fino alla risoluzione finale del caso.
Moltissimo spazio è dato al modo in cui l’assassino – Massimo Giuseppe Bossetti – è stato catturato: la ricerca del DNA compatibile con quello ritrovato sugli indumenti della giovane, attraverso l’esame genetico di tutti coloro che abitavano nei paesini coinvolti dall’accaduto.
A essere raccontato è anche ciò che avvenne tre mesi prima, nel momento della scomparsa di Yara. E non mancano incursioni nella sua mente e nei suoi pensieri – attraverso la lettura di passi del suo diario -, nella vita privata della sua famiglia e di quella del pubblico ministero incaricato del caso, Letizia Ruggeri.
Ma queste piccole digressioni non sono sufficienti per discostare la pellicola da una narrazione statica e fin troppo lineare di un caso di cronaca fra i più famosi. Sembra quasi che il regista, consapevole della notorietà dei fatti, non si sia voluto prendere alcuna libertà, eliminando qualsivoglia approfondimento psicologico e non osando nel modo in cui ha narrato la storia.
Un timore quasi reverenziale nel toccare un caso così delicato ha mosso quindi Tullio Giordana nella stesura del film. Allo stesso tempo, pare che il cineasta si sia fatto inglobare all’interno di una macchina prima mediatica e successivamente produttiva e distributiva più grande di lui. Ricordiamo, infatti, che Taodue – la casa delle fiction – ha prodotto la pellicola scritta da Pietro Valsecchi e Graziano Diana, autori di film, ma soprattutto di tantissime serie tv italiane. Per poi approdare su Netflix, dove i prodotti italiani non sono ancora riusciti a ottenere un vero e proprio salto di qualità.
Yara, quindi, si prospetta più come un documentario che come un lungometraggio. Di conseguenza, anche tutti gli altri elementi filmici seguono questa direzione e contribuiscono ad acuire la sensazione di trovarsi davanti a una fiction televisiva. Il montaggio è lento e lineare, nonostante i salti temporali, e le lunghe didascalie a fine pellicola – le quali spiegano cosa accade dopo il processo – ci ricordano di essere davanti a un prodotto il cui scopo rimane essenzialmente quello di ricostruire una storia vera nella maniera più fedele possibile.

Anche le interpretazioni risentono fortemente di questa direzione. Gli attori, infatti, sono alle prese con personaggi poco empatici e non molto caratterizzati, che si limitano a vivere in base alla funzione che hanno avuto nella vicenda: genitori disperati, fratelli troppo piccoli per comprendere ciò che sta accadendo, forze dell’ordine impegnate in un caso molto complesso.
In un cast composto da volti più o meno noti del grande e piccolo schermo (Alessio Boni, Thomas Trabacchi, Roberto Zibetti, Mario Pirrello) spicca solamente Isabella Ragonese nei panni del pubblico ministero Letizia Ruggeri, che qui assurge a una sorta di eroina che si muove contro forze avverse e risolve il caso grazie alla sua determinazione e alla sua empatia nei confronti della giovane vittima.
La pellicola rimane un prodotto a metà, schiacciato da intenzioni contrastanti e dai molteplici generi a cui avrebbe voluto appartenere. Dimostrando che, non sempre, una storia resa “buona” dai media può diventare un lungometraggio convincente.
Certe storie è meglio lasciarle nella cronaca e nei ricordi di quanti le hanno realmente vissute.
Se si decide invece di trasformarle in racconto bisogna avere il coraggio di osare, anche e soprattutto per rendere un giusto omaggio alle vittime. Nel cinema bisogna trovare la giusta chiave di lettura, che giustifichi il “ritornare” su questo tipo di tragedie. Altrimenti la narrazione pedissequa di crimini così sconvolgenti va lasciata ai telegiornali.