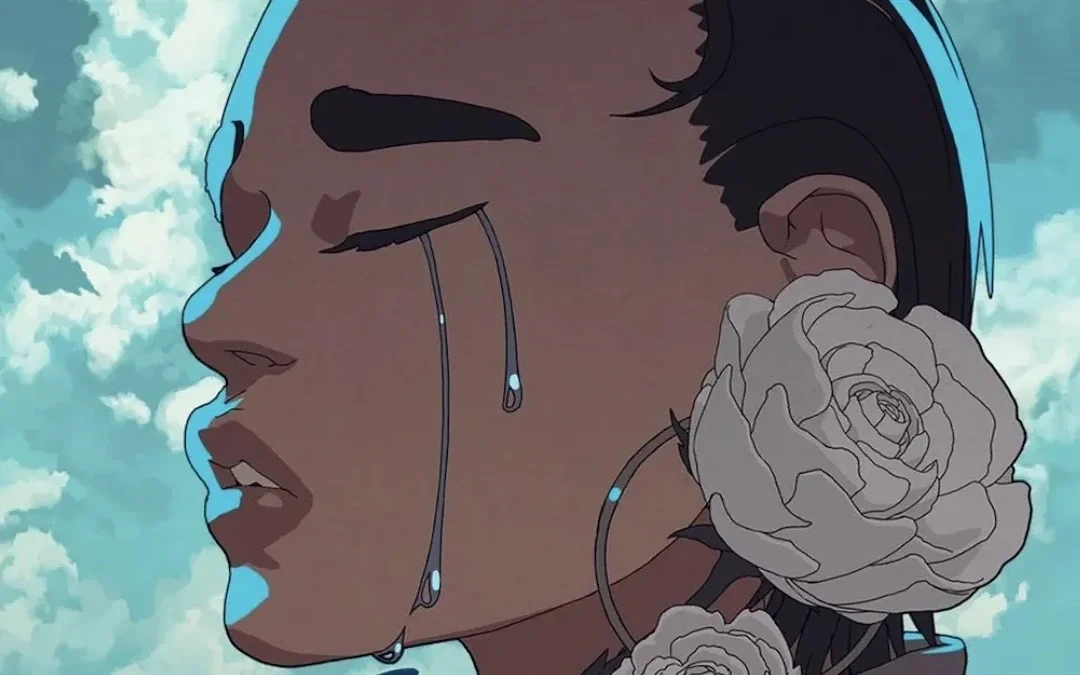Quante persone si lavano nel Gange? Come funziona una comunità di vagabondi? Come si diventa un sicario dei Narcos messicani? Cosa fa una prostituta romana quando non lavora? Di cosa parlano i lampedusani nel quotidiano? Come ci si guadagna il pane nei territori del Medio Oriente in guerra? Domande ai limiti dell’ordinario, totalmente estranee alla vita profondamente routinaria che conducono quasi tutti; eppure, nella loro assurdità, sono testimonianze granitiche di un disagio comune a tutti gli esseri viventi. Segnali della profonda fragilità dell’esistenza, che da un giorno all’altro può essere sconvolta da eventi tragici e insondabili; storie di uomini e di donne ai confini della vita, eppure vivi. Questo è il viatico del cinema di Gianfranco Rosi.
La storia registica di Gianfranco Rosi inizia circa trent’anni fa; all’alba degli anni ’90 quando lui, fresco di Accademia a New York, decide di partire per un viaggio verso l’India, alla ricerca della propria essenza. Vagando per Bagram, alla ricerca di qualcosa che possa stuzzicare la fantasia; camminando nella foresta di corpi umani che popolano le scale che digradano verso le sponde del Gange, incappa in un barcarolo. E proprio lì, inizia il suo viaggio, cinematografico e personale. Navigando in un guscio di noce sulle onde del fiume sacro, in compagnia di uno strano Caronte, un po’ psicopompo e un po’ filosofo.
Nell’arco di tutta la sua filmografia, Rosi ha vissuto il documentario come una missione vera e propria; India, Roma, Siria, Lampedusa, luoghi e ambientazioni provenienti dagli angoli più disparati del mondo, legati da un filo comune. Un fil rouge, è proprio il caso di dirlo, fatto di sangue e sofferenza.
Tante storie per un unico obiettivo: raccontare il dramma di essere umani; il dramma di essere mortali, fragili, effimeri. I protagonisti sono tutti travolti dal ciclone degli eventi, troppo piccoli per rendersi conto appieno di quello che succede. Senza saperlo sono al centro della Storia, stanno vivendo accadimenti straordinari che di lì a poco saranno impressi sui libri di scuola.

Boatman (1993)
Dal Gange fino ai monti della Siria, passando per il Messico e Lampedusa; tante pellicole, un unico lunghissimo afflato, poesia nella sofferenza e poesia della sofferenza. Per la sua tendenza a rappresentare in maniera quasi pittorica scene di profonda sofferenza e disagio, Gianfranco Rosi ha attirato su di sé numerose critiche: la tendenza a rendere in maniera visivamente poetica momenti tragici e drammatici non è stata vista di buon occhio da numerosi spettatori. Tuttavia, mettendo insieme le tessere di un discorso cinematografico ancora in corso, è impossibile non ravvisare un amalgama che, attraverso la morte e la sofferenza, porta al trionfo della vita.
Vita, morte, esistenza secondo Gianfranco Rosi
Non è un caso, quindi, che nel caleidoscopio di figure che affollano i documentari di Gianfranco Rosi, ce ne sia sempre almeno una pienamente positiva. A eccezione di Boatman (1993) e El Sicario (2001), in cui i protagonisti assumono anche il ruolo di traghettatori sullo Stige delle loro pene passate e future; per il resto c’è sempre un uomo, una donna, o un gruppo che si fanno carico di portare sulle spalle il peso del destino di tutto un mondo.

Below Sea Level (2008)
Il water guy di Below Sea Level (2008), che porta l’acqua e la vita, nel deserto, scambiando due parole, regala un pizzico di conforto a tutti i diseredati che abitano quelle lande desolate. O anche il botanico di Sacro GRA (2013), l’ultimo baluardo contro il punteruolo rosso; se è vero che la palma sia il simbolo dell’animo umano, questo supereroe occhialuto e dimesso vuole salvare l’umanità intera dalla marginalità, curando una pianta alla volta.
Per poi arrivare al medico di Lampedusa, immortalato in Fuocoammare (2016); testimone di tante morti, di cotanto sfacelo umano, eppure ancora capace di emozionarsi di fronte al miracolo della vita che sboccia. E infine al battaglione di donne siriane in Notturno (2020); esiliate sulla cima del monte, come monache amanuensi impegnate a serbare il fuoco della civiltà, di fronte all’avanzare della barbarie. Quello che accomuna personaggi così diversi è la refrattarietà alla realtà in cui sono calati; circondati da un mondo in totale sfacelo, sono ancora capaci di guardare al futuro in maniera fiduciosa, senza farsi abbattere da un presente non all’altezza.
Uguale piglio speranzoso, Gianfranco Rosi lo mette anche in una contrapposizione che ricorre spesso nelle sue opere: quella tra infanzia e morte.
Entrambi elementi onnipresenti, sotto diverse sfaccettature. La morte, coi suoi riti sempre diversi, viene spesso guardata con attenzione quasi morbosa; a partire dalle cerimonie indiane sul Gange, coi corpi che galleggiano e vagano nel fiume, fino al pianto straziante di una madre siriana. Si può notare un interesse quasi antropologico, nel modo in cui si osservano e riportano questi scorci di esistenza; come puntare un faro su come si esorcizza la paura della morte e la sofferenza di una perdita ai quattro angoli del mondo conosciuto.

Sacro GRA (2013)
Gli fanno da contraltare i volti e i corpi di bambini sempre diversi, per colori e voci e accenti, ma tutti uguali nella loro joie de vivre. Bambini che giocano, che ballano, bambini solo disegnati o che disegnano; ma soprattutto, l’infanzia viene ritratta a tu per tu con le brutture del mondo. Il caso dei bambini siriani, con le loro storie dall’inferno di Daesh, è solo la punta di un iceberg; in realtà, a ogni latitudine, l’infanzia si trova a dover combattere con una realtà che vorrebbe rubargli il gioco e l’innocenza. Per fortuna, ci sono ancora i pastelli per colorare un’esistenza grigia, e il canto degli uccelli a regalare una melodia dolce al silenzio delle metropoli.
Elementi di estetica rosiana
Oltre agli elementi prettamente narrativi, Gianfranco Rosi riporta in tutti i suoi documentari una cifra stilistica inconfondibile. La sfida principale che ogni opera documentaristica si trova davanti, nel lavorare con il mondo reale e non con attori che studiano e si preparano, è quella di trarre fuori autenticità; superare lo scoglio del bias connesso alla telecamera, annullare la tendenza di ognuno a impersonarsi pur di apparire, per tirar fuori una testimonianza quanto più viscerale possibile.
Rosi ci riesce sottoponendo i protagonisti a delle inquadrature lunghissime, che potremmo quasi definire autoptiche; i secondi che passano, mentre l’obiettivo resta immobile a spiare i volti e i gesti delle persone. Il regista, in questo caso, sceglie di portare avanti un lavoro certosino e paziente; utilizza tempi lunghi e camera immobile, come un predatore in agguato. In questo modo, si sforza di cogliere il momento in cui l’essere umano toglie la maschera del personaggio, per tornare a essere sé stesso. Pur di riuscire nel suo intento, il cineasta è disposto a lavorare e riprendere anche per anni; questo il motivo principale di una produzione “scarna”, a discapito di circa trent’anni di attività.

Fuocoammare (2016)
Altro elemento caratteristico dell’estetica rosiana sono le riprese dei paesaggi fatte dall’alto. Il contrasto tra l’agire umano, così frenetico e rumoroso, e la sostanziale pacatezza del circondario è spiazzante. Che si tratti del Messico, del Grande Raccordo Anulare o del Mediterraneo di notte, il paesaggio resta pacifico e indifferente; Gianfranco Rosi prova a dare una nuova definizione di sublime. Non c’è altro modo per definire la sensazione che provoca l’immagine del mare blu, immanente, che fa da sfondo alle voci strazianti dei migranti che chiedono aiuto; oppure l’idea di fumare il narghilè su un tetto in Siria, cullati dalla eco lontana degli spari del fronte.
«Detach ourselves from our personal experience, […] to bring reality a little further. To poetry, maybe».
(Gianfranco Rosi)
Gianfranco Rosi, un silenzio pieno di parole
Tutti questi elementi, narrativi ed estetici insieme, sono piccole briciole sulla strada per narrare della fragilità e della profonda solitudine dell’uomo moderno. Ambito di ricerca preferito di Gianfranco Rosi, che esplora in tutti i suoi film, variando i luoghi in cui sono ambientate le storie, per rafforzare il senso universale di questa condizione. Il modo unico e migliore per colmare quel senso di vuoto è attraverso le parole. Parole vuote, circostanziali. Salvo rare eccezioni, come il racconto del Sicario (che però esce del tutto fuori dai canoni narrativi rosiani), o, anche, come le preghiere dei migranti e i racconti dei bambini siriani.
È la paura del silenzio, più che la necessità di comunicare, che spinge tutti a parlare; l’ansia di rimanere soli con sé stessi, di affrontare il proprio personalissimo punteruolo rosso, che mangia l’anima. Timore introiettato, ma privo di fondamento perché, come insegna il barcarolo di Bagram, non ha alcun senso porsi tante domande. Quella sequela infinita di dubbi, che secoli di illuminismo e logica hanno reso tiranni del pensiero, allontanano la mente dell’uomo dalla sua natura profonda e archetipica. Per strada si è smarrito il “sense of wonder“, la capacità di stupire della vita; sostituito, invece, dall’angoscia razionale di un nesso causale da trovare a tutti i costi.

Notturno (2020)
Con la sua opera Gianfranco Rosi rivoluziona il modo di creare il documentario.
Innanzitutto, la cura nei particolari; il lavoro quasi maniacale che mette nel girare in presa diretta, lo hanno quasi costretto a riunire in sé figure diverse. Non più solo regia, quindi, ma anche scrittura, fotografia, sonoro, produzione; niente viene lasciato al caso e, pur di provare ad avvicinarsi il più possibile all’ideale immaginato, non contano gli anni di lavorazione necessari. Il lavoro di montaggio è immane; provare a dare coerenza filmica al girato raccolto su un arco pluriennale, richiede uno sforzo titanico. Eppure, la sua poetica non perde in freschezza, suscitando emozioni spontanee e viscerali.
Le opere di Rosi dicono molto senza, però, la spocchia di chi vuole insegnare qualcosa; sono dei viaggi, delle esperienze pregne di significato, prive della presunzione di chi vuole dare lezioni di vita spicciola. La chiave è abbandonarsi alle immagini, lasciarsi guidare dalle emozioni, sospendendo per un attimo il raziocinio. Non si può comprendere razionalmente la scelta di attraversare il Mediterraneo, o il dolore delle torture di Daesh; ma lì dove la mente non arriva, a guidarci dovrebbe bastare il cuore. Un grande senso di sympatheia, per abbracciare la tribù degli esseri umani e riconciliarsi con la nostra ineluttabile fragilità.