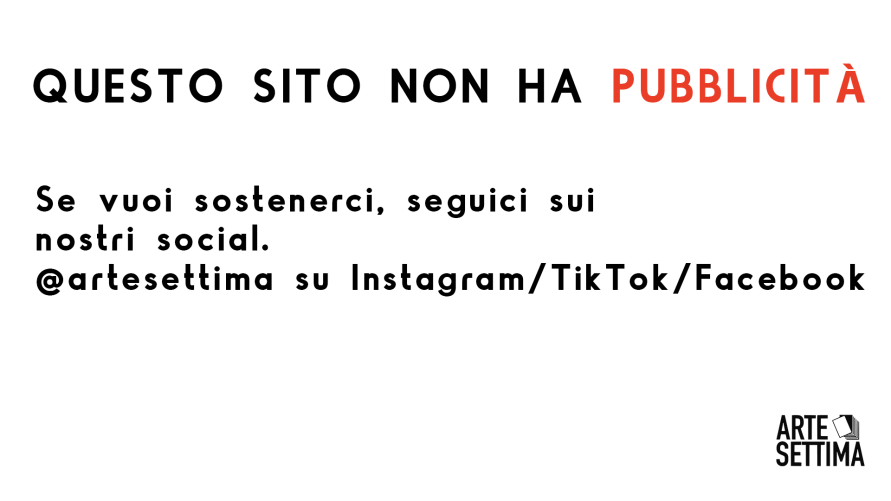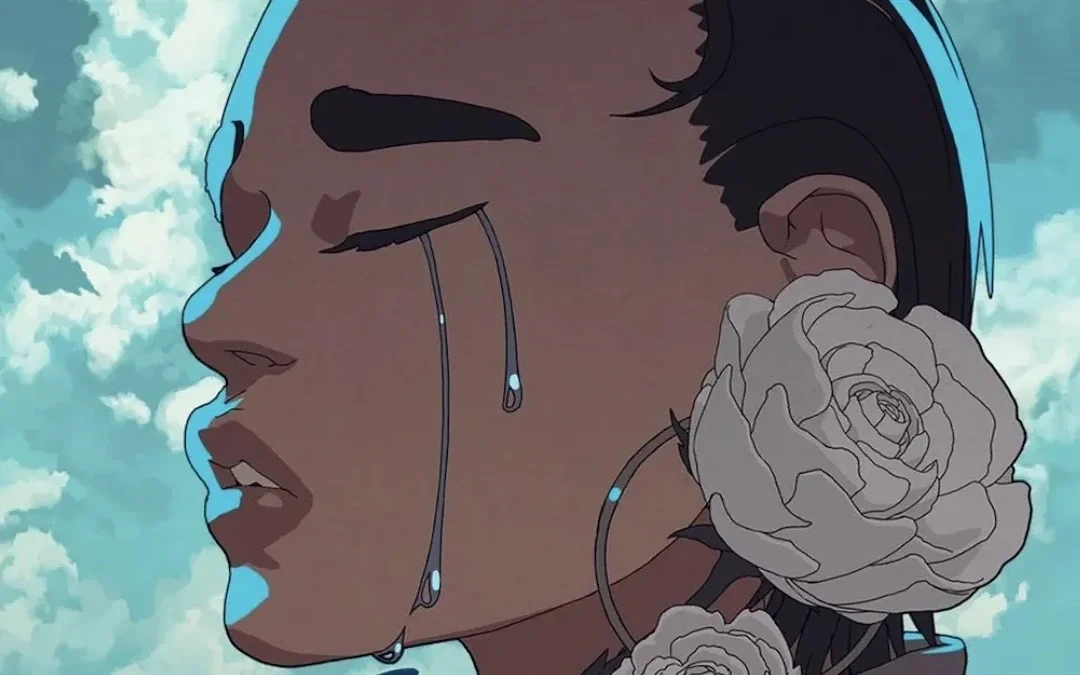«Io il regista non lo volevo fare, perché secondo me il regista deve essere veramente un genio, e poi stavo tanto bene a fare il direttore della fotografia, guadagnavo un sacco di soldi».
(Mario Bava)
A quarant’anni dalla sua scomparsa, Mario Bava rimane una delle figure più centrali dell’intero cinema italiano di genere. Sebbene egli stesso si fosse spesso definito un “artigiano” (si pensi alla genuinità nell’utilizzo degli strumenti cinematografici più rudimentali, spesso conseguenza di budget fortemente ridotti, all’immediato sfruttamento di un’idea oppure agli effetti speciali casalinghi), è inoppugnabile che il suo sguardo possedesse l’essenza di una fantasmagoria. Egli riusciva a sfruttare trucchi e dispositivi ottici per creare mondi illusori e indipendenti rispetto al reale.
La sua grande capacità, come accenna Tim Lucas, era quella di saper interpretare il materiale che gli veniva fornito imponendo ai lavori la sua personalità. L’idea che Bava aveva del cinema era infatti molto mélièsiana: prediligeva il trucco e l’illusionismo, divertendosi a stupire il pubblico con effetti mirabolanti sia fotografici che speciali.
L’incontro/scontro tra il regista sanremese (definitosi quindi “artigiano”, non-autore e regista di genere) e la critica europea dell’epoca (che lo definiva invece “autore”) suggellò, all’interno del panorama cinematografico nostrano, lo status di anomalia, specie con la prosecuzione, negli anni successivi alla morte, degli studi sul suo operato.
Sorpassando la pletora di disquisizioni sul ruolo baviano all’interno del panorama cinematografico, il contributo di Mario Bava alla codificazione di generi come il giallo all’italiana (La ragazza che sapeva troppo, 1963), lo slasher (Reazione a catena, 1971) e l’horror gotico (La maschera del demonio, 1960) è innegabile.

A rappresentare un unicum all’interno della sua carriera, però, è sicuramente Cani Arrabbiati, film “maledetto” del 1973, dove Bava ha finalmente potuto esprimere una propria visione del mondo e della società fuori da ogni ironia autodissacrante.
Ambientato nella città di Roma, il film narra la storia di tre rapinatori che effettuano un colpo al portavalori di una ditta farmaceutica. Inseguiti dalla polizia, s’impadroniscono di un’autovettura e portano con loro tre ostaggi.

A causa del fallimento della casa di produzione, la Loyola Films, il film non venne distribuito fino al 1995, anno in cui l’attrice Lea Kruger (che interpreta la donna presa in ostaggio) decise di finanziare personalmente la post-produzione, permettendogli di vedere finalmente la luce e di uscire in DVD.
Della pellicola esistono varie versioni: le più popolari sono quella trasmessa da Sky nel 2004 (dal titolo Semaforo Rosso) e quella rimaneggiata dal figlio e dal nipote di Bava (conosciuta negli Stati Uniti con il titolo Kidnapped), anche se meno apprezzata da critica e pubblico a causa di un montaggio approssimativo, un pessimo doppiaggio e una colonna sonora completamente riscritta.
A differenza degli altri film di Bava, in Cani Arrabbiati l’orrore non è più presente a livello di trucco scenico, ma è celato nell’interiorità dei protagonisti.
Il modo in cui il regista combina le dinamiche da road movie con una narrazione secca ed essenziale, costruita su un’unica unità di tempo, di luogo e di spazio, diventa quindi anche il modo stesso con cui egli indaga le atrocità dell’animo umano.
Lo spazio del racconto è angusto e stretto (un’autovettura) e la sua composizione avviene principalmente attraverso l’utilizzo di frequenti e aggressivi zoom, che ne delineano il carattere asfissiante, oltre a fungere da soluzione espressiva per definire le condizioni psicofisiche dei personaggi e per lavorare sulla tensione.
Se nel cinema di Bava il profilmico ideale è sempre stato l’oggetto di scena piuttosto che l’attore, qui vi è un approccio contrario. Quel senso di artificiosità che tanto caratterizzava le sue opere precedenti viene ora a mancare. È l’attore stesso a divenire oggetto tensivo, tornando insistentemente davanti alla camera per disturbare lo spettatore.
Attraverso l’utilizzo dello zoom Bava compie quello che è un sottile lavoro di astrazione. Il lavoro sui volti, insieme ai dialoghi turpi e discontinui, riduce i personaggi a punti, a manifestazioni ributtanti degli istinti più primordiali.

Come accennato nelle prime righe di questo articolo, l’interesse di Mario Bava per i generi si è sempre posto alla base del suo approccio al mezzo cinematografico.
Nel caso di Cani Arrabbiati si attinge principalmente dall’immaginario noir, tipologia cinematografica affermatasi a Hollywood sotto l’influsso dei cosiddetti romanzi hard-boiled (rappresentazioni realistiche della violenza, del sesso e del crimine).
Tuttavia, all’atmosfera fumosa e plumbea del noir vengono sostituite la luce e il caldo torbido del sole, che accompagneranno i personaggi in una folle fuga verso la salvezza.

Rispetto ai suoi lavori precedenti — specialmente in film come 5 bambole per la Luna d’agosto (1970), Sei donne per l’assassino (1964), I tre volti della paura (1963) —, anche il montaggio svolge un ruolo diverso. La scelta di situare lo svolgimento della storia prevalentemente all’interno di un’automobile, seguendo quindi la struttura base del road movie, stabilizza infatti il ritmo, che, pur rimanendo estremamente frenetico, si costruisce a partire da un assemblaggio di inquadrature piuttosto composto.
L’intenzione non è quella di disorientare il piano percettivo dello spettatore o di stupirlo attraverso formalismi ed esercizi di stile (si notino le varie operazioni di taglio ed ellissi in Sei donne per l’assassino), ma di renderlo un partecipante attivo delle vicende vissute dai personaggi.

I piani stretti all’interno dell’abitacolo costringono lo spettatore a provare lo stesso senso di claustrofobia dei protagonisti. Il movimento, funzione cardine dei caratteri in molti dei film di Bava, qui è veicolato principalmente dalla macchina, mentre i personaggi sono “bloccati” dalla sua struttura interna, collocati spazialmente in piccoli riquadri scomodi.
Ciò che domina l’operazione di Mario Bava, quindi, ha sì a che fare con un dinamismo nevrastenico e malato (che dimostra il senso di un profondo contenuto estetico), ma è controbilanciata da una linearità narrativa che smorza qualsiasi possibile esagerazione fine a sé stessa.
Ecco perché, all’interno della filmografia baviana, questo film risulta essere una splendida anomalia, grazie al suo costruirsi in modo diverso rispetto al resto delle sue opere e al suo muoversi in maniera paradossale (le riprese in movimento dell’auto creano spesso un distacco tensivo da ciò che accade al suo interno, in un continuo gioco di contrappesi tra apparente normalità e follia nascosta).