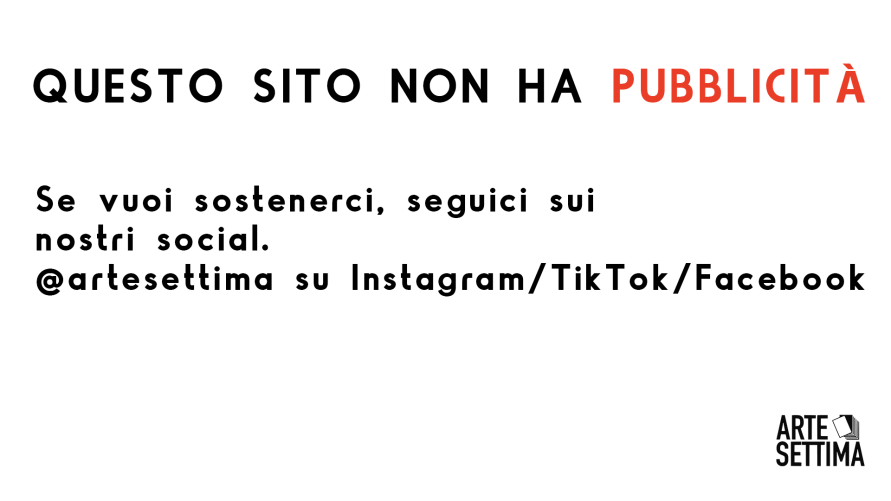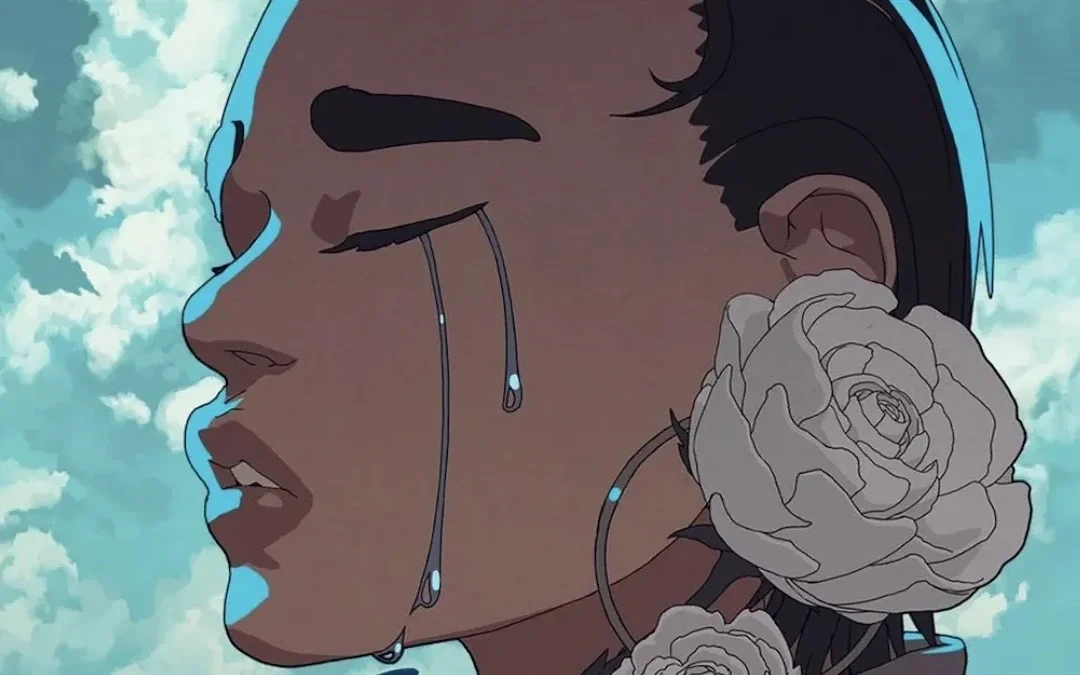L’esordio al lungometraggio – Forma documentaristica
Nella selezione ufficiale di Alice nella città 2021, festival del cinema parallelo alla Festa del Cinema di Roma, compariva un piccolo film con una proiezione unica. Un documentario indipendente italiano, Sacro Moderno, prodotto tra le altre dalla giovane casa di produzione Il Varco e diretto dall’abruzzese Lorenzo Pallotta, giovane regista classe ’92 che con questo interessantissimo documentario esordisce al lungometraggio, dopo aver diretto i due cortometraggi Ossa del 2018 e Luis del 2019.
La forma documentaristica, di cui si serve Pallotta nel racconto estremamente crudo e realistico di una vita complessa e solitaria, come quella della gente delle montagne abruzzesi, ricorda fortemente la cinematografia di alcuni autori che, come Pallotta, si sono focalizzati (alcuni a lungo, altri brevemente) sul cinema rurale, allegorico e poetico, nel suo ritorno al silenzio e ai volti di una realtà non costruita e apparente, bensì semplicemente filmata.

Per fare alcuni esempi di autori la cui visione torna immediatamente osservando la regia e poi le scelte di fotografia e impostazione narrativa di Sacro Moderno: i fratelli Dardenne (Rosetta), Werner Herzog (Happy People: A Year in the Taiga), Ermanno Olmi (L’albero degli zoccoli), Alice Rohrwacher (Lazzaro felice), Bouzgarrou-Jenkoe (The Last Hillbilly), Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro) e Amir Naderi (Monte).
Lorenzo Pallotta, così come gli autori sopracitati, costruisce molto poco a livello di narrazione e di messa in scena, concentrandosi sulla realtà e dunque sui volti talvolta allegri e talvolta cupi degli individui che intende presentare e raccontare.
Soffermandosi perciò sui loro silenzi di rassegnazione e consapevolezza – conscia e inconscia – rispetto a una condizione sociale piuttosto anomala, se calata nel contesto della modernità opposta al Sacro, oltre che complessa e dura come qualsiasi ideale di vita solitaria trascorsa nei paesini sperduti tra le montagne di ogni dove e destinati purtroppo a sparire sempre più rapidamente.

Fratelli
Nello scenario boschivo abruzzese che ricorda l’America di provincia di molto cinema recente, da Scott Cooper a Debra Granik, si muovono due fratelli. Il loro legame è saldo e si sviluppa nel corso di lunghe camminate tra i boschi e improvvise, ma necessarie, prove di coraggio.
I due fratelli rappresentano non soltanto l’adolescenza e la crescita, in una piccola realtà fatta di soli adulti e anziani, bensì il moderno inteso nella sua accezione più ampia e assoluta, che ha che fare tanto coi corpi, quanto con la mentalità e le idee.
Pallotta riunisce, per esempio, in alcuni momenti, gli anziani, in quello che sembra essere uno scantinato, o comunque in un rifugio di dimensioni ridotte, in cui si discute del futuro del paesino in cui il film è ambientato, così di ciò che ancora è possibile offrire ai giovani, evitando che fuggano per costruirsi una vita migliore.
In quei momenti i due fratelli restano in silenzio e ascoltano, mentre gli anziani parlano e riflettono. Ecco dunque il tema dello scontro, seppur silenzioso, tra remoto e moderno che un film singolare e memorabile – anche se poco ricordato – aveva presentato meglio di ogni altro, ossia The Village di M. Night Shyamalan.

Un film con il quale Sacro Moderno condivide diversi punti di contatto, a partire dalla modernità che resta celata, come se appartenesse a un altro mondo, estremamente distante dalle montagne dei due fratelli al centro del documentario di Pallotta.
Il rapporto tra i due giovani non ha niente di convenzionale. I dialoghi tra loro sono ridotti all’osso, e il senso dell’operazione risiede nella ricerca e poi nell’esaltazione della realtà filmata, che osserva dunque i silenzi, i volti, gli sguardi e perfino i pensieri, senza attribuire loro una costruzione cinematografica fittizia.
Simone e Mattia sono destinati però a dividersi, in nome di un ideale o più in generale di un sentimento che sembrano non condividere. Rispetto a questo, il momento della macellazione dell’agnello diviene la chiave di lettura e voce ultima di questa verità: c’è chi guarda e vive la violenza e c’è chi rifiuta, estraniandosi, poiché non vuole appartenervi.

L’uomo delle pecore
Una figura sicuramente interessante del film di Lorenzo Pallotta è Filippo, l’uomo delle pecore, che più di ogni altro individuo mostrato rappresenta la scelta dell’isolamento estremizzata a tal punto da presentarlo come un vero e proprio eremita che trascorre la sua vita in una casa diroccata, circondato dai boschi e dalle sue inseparabili pecore.
Nell’uomo delle pecore convergono tanto la follia quanto la disperazione, a sua volta legata a un sentimento per certi versi superiore che Filippo probabilmente nutre, nella speranza di continuare a sopravvivere in quelle condizioni, cioè la preghiera e il canto religioso. Questo è pur sempre condiviso con le pecore che per un po’ restano in ascolto, disperdendosi poco dopo nella radura boschiva. Filippo è solo, privato del dialogo.
Se in un primo momento Filippo appare come figura bizzarra e simbolica dalla carica positiva, diviene presto chiaro, soprattutto nella parte finale del film, quanto in realtà di positivo ci sia davvero poco, poiché ognuno di questi personaggi è destinato alla caduta e all’accettazione di quel male e quella violenza osservate prima nel furto e poi nell’uccisione dell’agnello.
Nella consapevolezza improvvisa e tragica – poiché fortemente destabilizzante – d’aver perso una parte di sé e di quella che considerava una famiglia (il gregge di pecore), Filippo perde la ragione sacrificando tra le fiamme tutto ciò che di più caro possiede. Il crollo e la caduta definitiva. Non c’è più speranza sulle montagne.

Il cammino delle croci
Sacro Moderno è in definitiva un esordio potente e interessante, che si serve con grande efficacia di una piccola storia dalla capacità evocativa e allegorica fortissima.
Basti pensare alla scena dell’addio, o per meglio dire, di un funerale tradizionale come lo si sarebbe visto in un western crepuscolare di Sam Peckinpah o Robert Altman, in cui il silenzio, gli sguardi e l’atmosfera si rivelano sufficienti e totali nella presentazione ed elaborazione del dolore e della perdita, anche e soprattutto in assenza di dialogo.
Il cammino delle croci rappresenta ciò che il film di fatto è, ossia un lungo cammino cupo e simbolico che lascia il segno grazie a un sorprendente realismo crudo e disperato, così difficilmente rintracciabile nel cinema moderno.