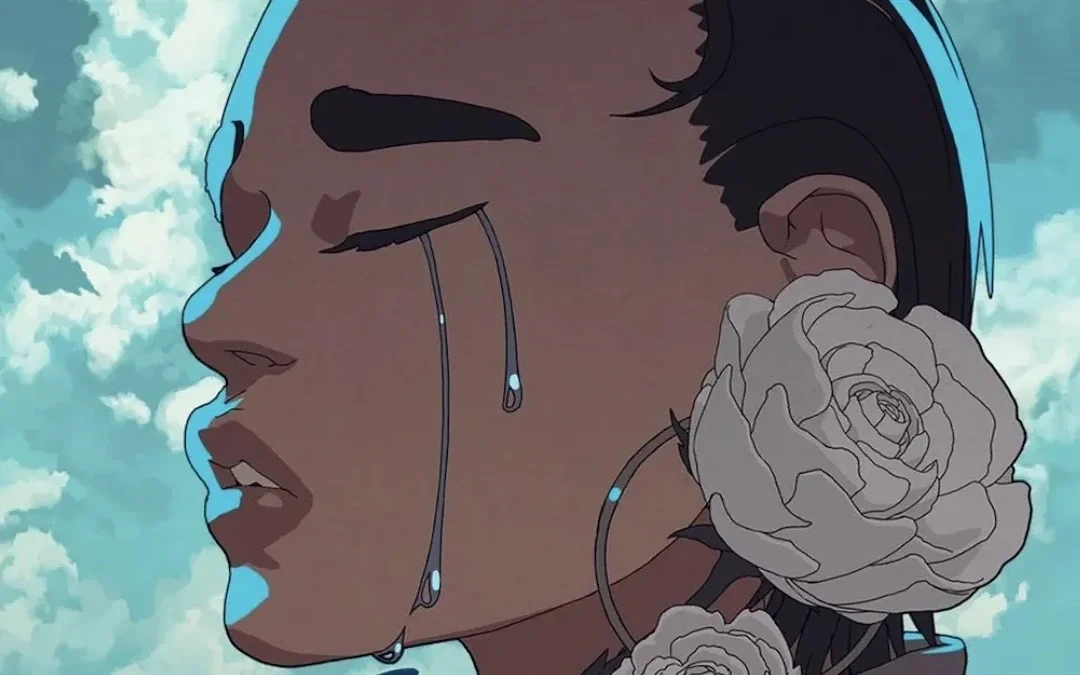Requiem for a dream, dalla regia di Darren Aronofsky, è un film del 2000 che apre al nuovo millennio cercando di tirare una sintesi tragica di ciò che i decenni precedenti avevano lasciato nella società occidentale.

Le scelte registiche di Requiem for a dream
Aleggia sulla pellicola un’atmosfera pesante, a tratti depressiva, che, confermata dalla regia cinematografica, vive nell’oscillazione angosciante tra anonimato e successo mediatico.
La macchina cinematografica, per amplificare la portata percettiva di certi significanti che emergono dalla storia – come una parola, un monito culturale o un’evidenza sociale -, si avvicina all’oggetto, spingendo lo spettatore a impattare maggiormente con quello stesso significante. Questi focus, così come le scene brevi, sono una martellata di stimoli con cui il regista aggredisce lo spettatore per arpionarlo alla tragedia dei protagonisti. In questo la regia cerca di rimandare, lungo tutto il film, la percezione del corpo come sostanza che gode e che cerca godimento.
Se qualcosa della percezione uditiva può poi riecheggiare in questo film anche nella percezione intima, questo è reso possibile grazie ad una colonna sonora storica (Lux Aeterna, Clint Mansell), che serra certe scene apicali nelle viscere della pancia dello spettatore.
La musica, emblema della tensione emotiva percepita, è spezzata a tratti da scene di suspance che rimandano, tramite una tecnica cinematografica di stoffa onirica, ad una realtà altra in cui si vive la forza di una pulsione o di una bellezza non imprigionate nelle maglie di una realtà sociale limitante.
L’immaginario si potenzia, nel bene e nel male, di fronte ad una realtà avvertita come frustrante.

Il tempo scorre inevitabile, gli oggetti di consumo si consumano da soli e non si afferrano mai davvero, l’ansia monta, una figura nuda davanti allo specchio svela la ricerca di godimento di un corpo che sfugge a sé stesso nell’atto del suo stesso impiego.
Ogni volta che il regista vuole mettere in evidenza l’esperienza di un personaggio vengono utilizzati la tecnica del point of view e la colonna sonora per sottolineare la solitudine affannosa che li mette a confronto con loro stessi. Alcuni flashback (come nel caso di Tyrone) cercano di ridonare spazio al fantasma di un passato che l’uomo contemporaneo, anche a causa della progressiva perdita del suo senso storico, ha smarrito.
L’aspetto thriller del film, anche quello rimandato benissimo dall’uso di un punto di vista preciso sui personaggi, viene suscitato da un crescendo di angoscia filtrato da paradossi registici che cercano di legare la percezione cinematografica alla struttura della compulsione (sia visiva che fattuale).
Per questa ragione, forse, il titolo invoca proprio una preghiera per un sogno, per aspirare a qualcosa che spezzi il passo all’automaton infernale del consumo.
Dunque, per entrare nel calcolo percettivo di questo film, si può dire che le tecniche alternative di ripresa, il fish eye, lo split screen, le sequenze di rappresentazioni accelerate e le riprese strettissime che montano su dettagli particolari (come la pupilla dilatata dopo l’assunzione di droga) rendono conto della tossicodipendenza e producono un effetto piuttosto conturbante sullo spettatore, che quasi affanna dietro un montaggio cosiddetto hip-hop, di cui si contano circa duemila tagli per un’ora e quaranta di film.
Un modo di fare regia che suggestivamente, e di proposito, fa venire la nausea. Nella compulsione finale di immagini distruttive si avverte una percezione alterata, come quella data dall’assunzione di eroina, o dalla dipendenza dallo spettacolo o dall’illegalità o ancora dal disprezzo verso l’altro, da un suo uso strumentale.
La disillusione
Il film, che apre la critica degli anni duemila ai mass-media, ci rimanda qualcosa del modo di vivere nel nuovo millennio: invisibilità e iper-presentazione, immagine e isolamento, condizione di essere sconosciuti, di vivere una vita che non fa audience per nessuno, o invece cercare di evadere da questo destino – che per la cultura dello spettacolo non può che essere additato come fallimentare – nella forma del successo mediatico (Sara, madre del protagonista) o economico (Harry, Tyrone e Marion).

C’è sin dall’inizio la droga, il suo rituale, come mezzo per raggiungere un più soddisfacente stato esistenziale. Nel film essa viene ad occupare il posto di prospettiva economica e dannazione personale, sia mezzo per raggiungere soldi sia ausilio per evadere dal perturbante che popola insidiosamente le maglie di ogni sua scena.
La vendita di droga, come il suo consumo, entrano nella macchina da presa nella successione coattiva di gesti sempre uguali, il cui contenuto di senso, rispetto ad un ammontare economico e di piacere che aumenta, non lascia di sé che un piccolo, obliante residuo.
Mentre la madre di Harry, vedova e sola in casa, cerca di presentarsi in un’apparenza senza difetto agli occhi del pubblico affamato di cui fantastica per colmare il vuoto di un’insensatezza esistenziale (o almeno di un’esistenza priva, fino a quel punto, di uno scopo formale), Harry vive con Marion un amore nel quale si mescolano aspirazioni di emancipazione a quelle di fuga. È la mira latente nella loro relazione che ne segnerà poi il concreto tragitto drammatico.
La cultura del successo, che permea tutto il film e che fa da cornice ad un narcisismo sempre più sfrenato, dice tutto ciò che è giusto fare o non fare – tutto ciò che è dell’ordine del comportamento estetico subisce un’invariabile pressione omologante. Nel sottotesto di una civiltà il cui maggiore punto di mira consiste nel diventare famosi, c’è un resto, il resto di tutto ciò che dell’essere umano non viene assorbito nella logica produttivistica. Di fronte all’ipertrofia di positivismo, c’è una nebbia melanconica e a tratti giustamente fastidiosa a percorrere questa pellicola.
La madre del protagonista, elemento del film senz’altro più deprimente e compassionevole, è lì per incarnare lo specchio di una società terrorizzata dalla vecchiaia, dalla linea da tenere, dai cibi da rispettare, dai capelli da avere a posto – in sostanza, dall’estetica. La sua solitudine la risucchia in una dipendenza che può essere paragonabile a quella della droga, cioè quella dell’immaginario della giovinezza e del successo.
«È un motivo per alzarmi al mattino, per sorridere» dice con disperazione Sara al figlio in un dialogo che mette a nudo tutte le sue mancanze e tutto il suo bisogno di amore. La medicina, al servizio dell’idolatria estetica del corpo, inietta invece siringhe di falsa autostima all’individuo contemporaneo.

La svolta sognata o ideale è quella non-detta del riuscire a tappare qualsiasi mancanza. Qui il benessere, come è sempre di più sponsorizzato tacitamente nella nostra società, corrisponde col pieno, col sentirsi pieni di cose da fare, per esempio, di obiettivi da raggiungere, di difetti da aggiustare, di routine da sostenere. La dimensione del vuoto è del tutto rimossa, ogni cosa cerca di essere riempita con quello che uno slogan televisivo durante il film recita «entusiasmo! entusiasmo!».
Qualcosa sfugge di mano, ad un certo punto della narrazione che, nel crescendo maniacale di euforia e disperazione, ci dimostra l’inconsistenza di vani obiettivi di successo.
Il destino nefasto di Sara giungerà fino alla de-realizzazione, resa tanto più forte dal declino annichilente, riflesso della medaglia mortifera, di Harry e degli altri personaggi.
A quel punto la realtà stessa, per come la vivono i personaggi nella loro storia e per come ce la rimanda il regista, si sostituisce alla fantasia, ridonandoci un immaginario mescolato di orrore e spettacolo. Qual è, dunque, la realtà che ci presenta il film?

Sembra che la litania del vincitore e del perdente faccia da bilanciere agli umori dei protagonisti di questo film che testimoniano così di una realtà deprimente, dal cui interno bisogna rubare qualcosa per emergerne quantomeno sopravvissuti.
Dov’è la compulsione? Non solo nei gesti ripetuti e coattivi del consumo, ma anche nel suo rovescio ossessivo di credere che l’essere esposti allo sguardo altrui rifletta il più alto grado di esistibilità. La madre costantemente esposta allo sguardo, reale o fittizio, e il figlio costantemente alle prese con l’evasione da questo sguardo. Entrambe le posizioni celano la natura angosciante di una realtà che viene preclusa e che per questo riappare nel Reale nella forma di una sorta di incubo allucinatorio, con frigoriferi che si muovono e personaggi da talk-show che invadono il salotto di casa.
Nell’ultimo capitolo del film, Winter, assistiamo allo sfacelo dei sogni dei personaggi con la conseguente perdita di contatto con la realtà. L’esaurimento della madre, l’astinenza di Marion, il vagabondaggio della speranza di Tyrone, la tossicomania di Harry, il buco inflitto, l’estasi attesa, l’abbagliante compulsione registica delle immagini – tutto testimonia di questa dissipazione di realtà e della sua sottrazione.
Non c’è risveglio, in questo film, non c’è salvezza, come dimostra l’assenza del capitolo primavera, come sancisce la caduta verso un baratro ipnotico.

Tutto questo movimento di euforia, declino e autodistruttività, come ci mostrano le scene finali, è rappresentato da Aronofsky in modo fortemente espressivo, seppur non giudicante, attraverso una realtà cruda per cui, alla fine del film, ogni personaggio perde qualcosa: Harry un braccio in cancrena, la madre Sara la sanità mentale, Marion la sua virtù, Tyrone la sua libertà in carcere.
Li ritroviamo tutti in posizione fetale come dei bambini che, per un attimo, possono prendersi una pausa dalla realtà.