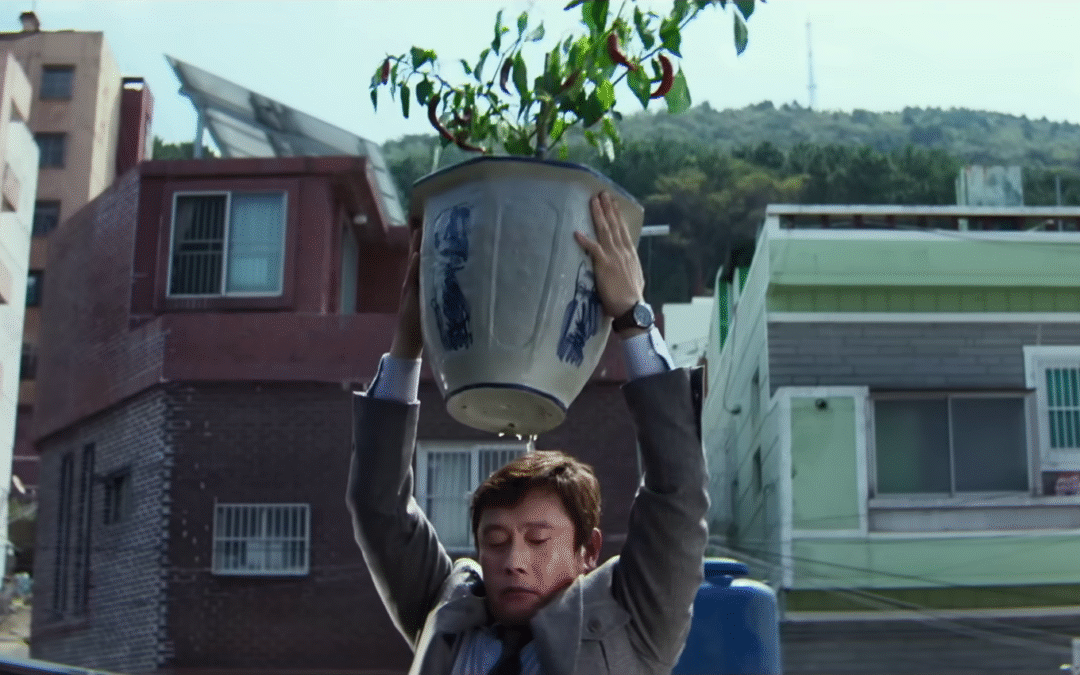Cosa successe nelle Ande nel 1972, dopo che un aereo si schiantò su una montagna lasciando i passeggeri in balia del destino? Ciò che accadde fu una tragedia o un miracolo per i superstiti? A questa domanda il regista Juan Antonio Bayona cerca di dare una risposta nel suo film, che ha rappresentato la Spagna agli Oscar di quest’anno: La sociedad de la nieve (La società della neve)
La pellicola è ispirata ad un fatto di cronaca nera risalente al 1972, quando un aereo uruguayano, diretto verso il Cile, precipitò sulla catena montuosa delle Ande e i sopravvissuti furono costretti a mangiare i compagni morti per alimentarsi durante il periodo di sopravvivenza. Questo evento suscitò un impatto mediatico che spinse i giornali dell’epoca ad evitare di speculare troppo sulla vicenda, proprio a causa della macabra decisione a cui furono spinti contro ogni tipo di etica e morale umana.
Lo stesso caso è stato già riproposto da due film: “Alive – Sopravvissuti” (1993) di Frank Marshall e “I sopravvissuti delle Ande” (1976) di Renè Cardona, ma, in questo caso, Bayona trova il modo per rendere la sua trasposizione unica e distinta dalle precedenti due, creando un gelido immaginario scandito da inquadrature a campo lunghissimo che si alternano a grandangoli in spazi angusti.
Il film si apre con una ripresa su una sconfinata distesa di neve sulla catena montuosa delle Ande, dove una squadra di rugby si troverà a lottare per la sopravvivenza con risicati viveri e la maggior parte dei componenti della compagnia feriti o morti.

In situazioni del genere, c’è sicuramente poco spazio per la morale: desolazione e freddo pungente sono tutto ciò che la squadra di rugby percepisce. Per forza di cose, la condizione in cui i protagonisti si trovano li spinge ad atti al limite dell’umano: lunghe spedizioni per trovare ciò che rimane dell’aereo e cannibalismo, dinamica trattata in modo sensibile e delicato, mai grottesco o banale.
Lo si capisce quando il regista pone l’attenzione sull’importanza di quelli che, tra i sopravvissuti, si erano offerti per tagliare parti dei corpi, lontano dagli occhi di tutti i compagni, affinchè i vivi potessero mangiare ignari di chi fosse la carne umana che stavano mangiando. Un concetto macabro, nascosto da una volontà di sopravvivenza che, purtroppo, in quella tragedia veramente accaduta, risultò determinante.
In che cosa potevano credere i sopravvissuti?
I personaggi, quindi, si riducono a mangiare chi non riesce a sopravvivere, secondo una sorta di patto con chi era precedentemente già moribondo. La scena chiave che ci spiega l’importanza della collaborazione a tutti i costi tra le persone sopravvissute risiede in un dialogo tra Arturo (Fernando Garcia) e Numa (Enzo Vongrincic): i due discutono su cosa si può credere nella loro situazione, quando ormai l’unica forza rimasta è quella dei compagni nel prodigarsi a cercare viveri e modi per sopravvivere e far sopravvivere.
Arturo Nogueira: «Credo nel dio che Roberto ha nella testa quando viene a curarmi le ferite, in quello che ha Nando nelle gambe per camminare senza condizioni, credo nella mano di Daniel quando taglia la carne […] senza dirci a quale amico apparteneva».
Questo, come altri dialoghi del film, riflette lo spirito e la “pulsione verso la vita” dei protagonisti ed è applicabile anche all’umanità nella sua globalità. Come sappiamo, però quest’ultima vive in bilico ogni giorno tra miracolo e tragedia, perchè l’umanità è ed è stata non solo fautrice di miracoli, grazie ad alcune persone o masse intere di esse, ma anche di tragedie, a causa di tutte le catastrofi che l’uomo ha lasciato compiere o che ha compiuto.
Colui che parlò di tragedia come somma rappresentazione della realtà fu Schopenhauer, filosofo idealista che definisce la storia come un’ immutabile tragedia di cui l’uomo è spettatore e fautore allo stesso tempo. Ciò che si contrappone all’immutabile tragedia della storia e, quindi, della vita, è la volontà di vivere, che Schopenhauer definisce come ciò che ci anima in modo irrazionale e impulsivo. E’ questo ciò che pervade i superstiti ad andare avanti, a opporsi ad una situazione tragica e uscire grazie alla loro volontà di rimanere in vita.
Dov’è la tragedia se, quindi, quella che si va formando è un’immagine eroica e speranzosa della sopravvivenza? Tutto sta nell’effetto irriducibilmente negativo della volontà di vivere, che risiede nella garanzia ad un’infelicità esistenziale propria di questi superstiti che, per quanto possano ingegnarsi nel sopravvivere, si guarderanno indietro e vedranno, sempre e indipendentemente dal loro eroismo, compagni morti tragicamente, sofferenze fisiche e psicologiche inaudite, il dolore dei cari che hanno esperito la mancanza di chi in quel momento si trovava sulle Ande con il gelido alito sul collo della morte.
Tutto, dall’inizio dell’incidente, è una scia di infelicità esistenziale che può essere interrotta solo da un momentaneo piacere per chi torna a casa salvo, ma non incolume e inconsapevole di ciò che ha passato. Qui inizia ad alimentarsi la condizione che caratterizza i sopravvissuti delle Ande: nel passato vedono le loro sofferenze e i loro compagni deceduti, nel presente percepiscono una disperazione dilaniante e nel futuro vedono una speranza di sopravvivenza barattata con il dolore, che sicuramente non avrebbero dimenticato facilmente.
I sopravvissuti, come ci dice Numa, non si sentono degli eroi: non ne escono felici o vittoriosi dalla tragedia, perchè il dolore delle perdite rimane una tragedia più dolorosa del miracolo avvenuto per i superstiti; anche loro in parte morti, coscienti di aver trascorso giorni infernali nell’ assistere alla morte dei propri amici, sono però desiderosi di rimuovere ogni ricordo legato a questa sofferenza.
Numa Turcatti: «Ma loro (i sopravvissuti) non si sentono eroi, perchè sono morti come noi e solo loro sono tornati».

Il peso della vita e per chi darla
Guardando La società della neve, è immancabile il paragone di situazioni al limite dell’esperibile già messe su pellicola, come in Cast Away (Robert Zemeckis) o Into the wild (Sean Penn), dove l’uomo si trova a dover sopravvivere in un continuo braccio di ferro con la natura che lo circonda. La differenza sostanziale con queste opere e La società della neve consiste nel come l’uomo riesca o meno nella sua impresa di sopravvivere alla natura.
Specialmente in In into the wild, troviamo un protagonista entusiasta di sfidare la natura con le proprie forze e che cerca di sfruttarla a suo vantaggio, ritrovandosi, da solo, a rimpiangere una felicità che poteva condividere con qualcuno al suo fianco ma senza averlo effettivamente fatto.
Dall’altra parte, nel film di Bayona, è la tragedia ad essere condivisa tra gli uomini, se pur accidentale, ma è proprio lo stesso dolore uguale per tutti che riesce a innestare quella pulsione verso la vita per salvare non solo se stessi, ma anche gli altri, creando, così, con le parole di Leopardi, una “social catena” attraverso la quale l’uomo può fidarsi del prossimo in modo reciproco e coeso, affinchè resista con tutte le sue forze all’inamovibile natura. Questo miracolo umano è attuabile solo grazie un atto di genuino altruismo, che innesterebbe, a sua volta, un continuo affratellamento tra uomini, capaci così di sopravvivere alle disgrazie della vita, proprio come nel film.
Il regista de La società della neve mette su pellicola fratellanza, resilienza, forza di volontà, superamento del dolore e speranza: tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno per sopravvivere non solo ad una catastrofe come quella del 1972, ma anche alla quotidianità. Tragedia non è solo un incidente aereo, ma anche la normale vita che ci troviamo ad affrontare e, proprio come nel film, nelle tragedie quotidiane si nasconde sempre la possibilità di un miracolo umano.